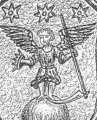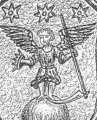|
___ 17 ___
C E N N I
SOPRA LA CHIESA DI ROVIGNO
Ove grandeggia
la presente chiesa di S. Eufemia era anticamente l'umile chiesa di Rovigno
(allora castello di pochi abitanti, se si considerano i
fabbricati entro la sua cinta, che ancora si vede) costruita come l'attuale
in tre navate e dedicata a S. Giorgio martire; la qual chiesa teneva sempre
il
primo luogo dopo la cattedrale, come si legge nella iscrizione, posta
a sinistra del coro mediano l'anno 1763.
Su le fondamenta di quella
consunta per vetustà, si eresse questa Parrocchiale Collegiata,
dedicandola alla suddetta Santa: dichiarata veramente
insigne da Monsignor Gasparo Negri Vescovo di Parenzo, cui è
soggetta nello spirituale, l'anno 1747.
Fu posta la pietra del nuovo
tempio l'anno 1725 agli 8 di maggio e condotto a fine nello spazio di undici
anni, cioè nel 1736, in nobile forma, qual si conviene a popolosa
e fiorente città, dalla pietà dei fedeli con pubbliche
e private largizioni; consacrato dal suddetto Vescovo l'anno 1756 ai 26
settembre,
come si rileva dalla iscrizione posta nel muro del presbiterio dalla
parte della Santa; nel quale incontro fu dispensata al popolo analoga medaglia
coniata in
Roma per memoria e divozione.
Al sommo di una collina,
che monte di S. Eufemia ora si chiama, e prima monte Rosso, per lo sangue
dei Martiri, che dicesi qui caduti per la fede di
Cristo, s'innalza questa chiesa, che deliziosamente domina da levante
la sottoposta città, le campagne sempre verdi per la folta piantagione
degli olivi ed i
limitrofi territorii, - da tramontana il vasto porto di Valdibora,
altra campagna a catena di colli olivati, alcuni scogli, ed a cinque miglia
vers'occaso il
castello di Orsera, di giurisdizione temporale dei Vescovi di Parenzo
sino al 1778; e lontano verso l'orto il quasi sempre nevoso monte Maggiore;
- da
ponente bellissimo e vasto orizzonte sulla superficie di un mare solcato
di continuo da navigli; - da ostro il bel porto di S. Catterina, per la
vaga isoletta di
tal nome che nel mezzo sorge, dov'era una chiesa con ospizio di Eremiti
ancor prima dell'arrivo a queste spiagge dell'arca di Sant'Eufemia da Costaninopoli,
e poscia dei padri Serviti dal 1486 al 1779, dei quali edifizii si
vedono tuttora le ultime ruine: il promontorio di Montauro, che fornì
le pietre per le
Procuratie ed altri magnifici edifizii di Venezia, e di recente (1840)
i massi per la Diga di Malamocco. Domina inoltre porzione della deliziosa
isoletta di
S. Andrea, abitata anticamente dai monaci Benedettini col nome di isola
Serra, e poscia dai padri M.O. di S. Francesco, che avevano un convento
fondato nell'ospizio dei primi, credesi da S. Giovanni di Capistrano, l'anno
1442, soppresso dal governo francese l'anno 1807, ora della ditta Stengle-Catraro,
che l'abbellì di coltivazioni, di viali, di un torchio per olii
a vapore, di fabbricati e di calcare; come pure parte dello scoglio di
S. Giovanni di Pelago, una
volta dei Camaldolesi, che restò disabitato fin dal 1668, per
la soppressione dell'ordine sotto Papa Clemente IX, poi dell'Abbazia Corniani,
ora della stessa
ditta, dove il Comune, proprietario di quella chiesuola e di qualche
rovina rimasta del piccolo convento, si è riservato il diritto di
approdo e di passo, a
comodo dei divoti: ed il bel Faro eretto dalla Borsa di Trieste l'anno
1853 sul contiguo scoglietto denominato S. Giovanni Piccolo.
Sorge, rozza al di fuori,
in figura quadrilunga la chiesa di S. Eufemia, fabbricata secondo il modello
dell'architetto Giovanni Dozzi, foggiato sulla forma
della vecchia chiesa, col campanile: l'una e l'altro di moderno lavoro;
eretto questo dal 1654 al 1687 del pari con pubbliche e private largizioni:
incominciato dall'architetto Antonio Sassola milanese del borgo di Lugano,
continuato dal 1668 dall'altro architetto Antonio Man pur milanese, e portato
a termine dal 1680
in poi dal terzo architetto Cristoforo Bellan: ristaurato l'anno 1854
a spese del Comune, della chiesa e del popolo dal nostro architetto Andrea
Battistella,
per zelantissima cura del sig. Angelo Rismondo allora Vice-Podestà:
e visitato durante il lavoro sino alla sublime cima il 24 giugno di quell'anno
dall'ora defunto Monsignor Vescovo di Parenzo e Pola Antonio dottor Peteani.
E' alto il campanile piedi
175, largo 22, con 25 di base, misura viennese, di forma svelta ed elegante;
le cui tre campane attuali, rifuse dal Canciani in Venezia dal 1793 al
94 e benedette da Monsignor Francesco march. Polesini Vescovo di Parenzo
li 24 marzo di quell'anno, furono poste a luogo dal nostro architetto Simon
Battistella dopo seguita la consacrazione delle stesse in onore cioè
la grande di S. Eufemia, la mezzana di Maria Vergine e la piccola di S.
Giorgio: tutte e tre del peso complessivo di libbre 4789, e lavorate ad
un modo, coi medesimi Santi, cioè il Crocefisso, la Madonna, S.
Giorgio e S. Eufemia,
e con una stessa iscrizione, la quale ricorda che furono rifuse col
denaro del popolo, chi lo raccolse, chi curava il lavoro e l'artefice.
Sull'ardua cima di questo campanile, che ha per base il monte stesso, alto
altrettanta altezza dal livello del mare, giganteggia la statua in rame
della Santa, di piedi 22 di Vienna, postavi l'anno 1758 in luogo dell'altra
di legno, che fu incendiata dal fulmine li 4 ottobre 1734; e questa si
aggira sopra perno pur di rame a seconda del vento: mirabile lavoro dei
valenti fratelli Vincenzo e Giambattista Vallani da Maniago (*). Il navigante
che questo golfo veleggia, da lungi la scorge e saluta, e dirige con fiducia
la prora al suo destino.
E sorge la chiesa con la
facciata a ponente, della quale è progettato intelligentemente da
lungo tempo il rivestimento. Tre porte, alle quali si ascende per comoda
gradinata, dànno ingresso alle tre navate con grandi archi per ogni
verso di stile toscano modificato; spiccando una parte del fianco esterno
vers'ostro, ov'è un quarto ingresso, rivestito l'anno 1780, a spese
della chiesa stessa, di archi in liscia pietra, di lavoro corrispondente
all'interno, fatto dal sunnominato aerchitetto Simon Battistella. Sopra
gli architravi delle quattro porte sono scolpite dell'epigrafi, riferibili
al titolo delle navate e danti, meno la maggiore, l'epoca delle porte stesse.
Bella è la chiesa
all'interno (lunga piedi 160 e larga piedi 92, misure di Vienna) e per
lo suo squisito lavoro, e per la profusione dei marmi, e per li suoi regolari
altari, e per la ricchezza e buon gusto degli addobbi e dei paramenti,
il che tutto piacevolmente armonizza.
Bello sopra ogni altro altare
è il maggiore, isolato, di marmo di Carrara, adornato del più
bell'Africano; sopra cui di S. Giorgio martire, primo titolar della chiesa,
avente ai lati quelle di S. Marco evangelista e di S. Rocco confessore;
tutte e tre di terso Carrara e di buon lavoro.
Sono anche belli i due altari
a giorno del SS. Sacramento, e di S. Eufemia, sopratutto per le pregiate
colonne; dietro il qual ultimo in grande arca di marmo greco si venera
il corpo della gloriosa vergine e martire S. Eufemia di Calcedonia, il
cui martirio si celebra annualmente con festa solenne, sagra e processione.
Sono pure pregevoli i due altari laterali di S. Pietro Apostolo, e del
serafico S. Francesco, che furono eretti l'anno 1779, del più bel
rosso di Francia, per mano
di Giovanni Mattiussi di Udine: il primo a spese della scuola laica
dei pescatori, il secondo di quella di S. Francesco. E' l'immagine del
serafico lodevole lavoro
del pittore Giambattista Mengardi padovano, ristaurata l'anno 1845
da Giaacomo Tonegutti bellunese; il quale ristaurò l'anno dopo la
Cenaa di Cristo, Cristo nell'orto e i tre dormienti Discepoli, lodevoli
pitture anche queste che ora adornano le pareti del coro di mezzo.
E' degno di particolar attenzione
l'antipendio dell'incurato altare dell'Arcangelo Michele, lavorato in marmo
di Carrara ad alto rilievo l'anno 1739 dallo scultore Alvise Tagliapietra
di Venezia. Nel mezzo stà il guerriero principe degli angeli, che
tiene debellato sotto il piede il drago infernale; ai lati ornato di fiori
e di frutta di gusto elegante e di squisito lavoro.
Ha questa Chiesa una Sacristia,
che fu perfezionata l'anno 1803, spaziosa e ben tenuta, con all'ingiro
armadii di noce di pulito lavoro, altare di pietra e marmi, ed ornata di
pregevoli pitture in belle cornici.
Si vuole che la Chiesa in
oggi collegiata di Rovigno fosse Cattedrale prima dell'arrivo di S. Eufemia,
avvenuto il 13 luglio 800; ma tanto vi è corso di
tempo, tanta è la oscurità delle tradizioni e la dubbiezza
dei documenti, che non si osa affermarlo, sembra però che all'epoca
803 questa chiesa fosse tuttora Cattedrale, e si volge l'occhio al Diploma
dell'Imperatore Carlo Magno dei 4 Agosto di quell'anno, col quale assoggettava
l'Episcopato di Rovigno
(Episcopatus . . . Rubinensem) in unione ad altri cinque suffraganeo
al Patriarca di Aquileja.
Come questa Chiesa abbia
perduto di poi un così illustre titolo, si raccoglie dalla Bolla
di Rodaoldo, uno di quei Patriarchi, del di 22 Gennajo 966 (**); poichè
qualche anno prima venne dai popoli barbari messo a ferro e fuoco tutto
il paese, e restò miseramente distrutto Rovigno. Per la qualcosa
quel Patriarca con l'autorità che aveva in forza del predetto Diploma,
ne assoggettò i miseri avanzi alla giurisdizione vescovile di Parenzo,
come città più vicina, e donò a quella Mensa, onde
soccorrere quella Chiesa dalle calamità nelle quali era caduta,
le rendite dell'Episcopato di Rovigno. Anche nella Bolla del Pontefice
Sergio IV del 1010, con la quale conferma al Vescovo di Parenzo i doni
ricevuti, si riscontra nuovo argomento di poter ritenere, che in antico
questa Chiesa era Cattedrale, mentre parlando di Rovigno dice: "ubique
Episcopatus dicitur fuisse.".
Comunque siano questi documenti,
è costante tradizione però, che il Vescovo di Parenzo per
la fusione seguita dell'Episcopato di Rovigno con quello di quella città,
doveva risiedere una metà dell'anno in Rovigno, dove aveva proprio
edifizio, chiamato Vescovado nei pubblici atti ancora dell'anno 1643, e
di poi Canonica o palazzo episcopale in un atto del 1724 concernente la
nuova fabbrica della Chiesa; edifizio questo sul Monte di S. Eufemia, verso
tramontana, e congiunto alla vecchia Chiesa mediante un'ala che, attaccata
ancora alla nuova, fu atterrato l'anno 1781. Il Vescovo Cesare Nori aveva
ristaurato quell'edifizio l'anno 1584, ponendovi analoga iscrizione, il
quale sussisteva diroccato per abbandono sino a che l'anno 1850 fu intieramente
abbattuto e perfino spianato il macigno su cui posava, per ordine del Comune
divenuto proprietario verso canone enfiteutico fin dal 1735, onde dar pane
ad alcuni poveri operai.
Inoltre qual segno di antica
condizione vescovile di questa Chiesa esisteva fino l'anno 1810 in Rovigno
un Offizio di Vicario episcopale, ch'esercitava qualche giurisdizione in
nome del Vescovo di Parenzo, il quale mediante il dett'offizio facea datare
gli atti che riguardavano Rovigno colle precise: "Rubini, ex Cancelleria
nostra Episcopali". L'uso infine, che hanno questi Canonici della zanfarda,
denota un privilegio antico annesso al fu Episcopato di Rovigno: distintivo
questo, contrastato dai Vescovi di Parenzo e da quel Municipio, ai quali
erano invisi i privilegi di questa Chiesa, e difesa da questo Capitolo
fin dal 1693 presso la Suprema Autorità dello Stato, fu finalmente
allo stesso Capitolo; onde così troncare il dispiacevole litigio
che da lungo tempo perdurava, fatto ottenere dal Diocesano Mons. Negri
l'anno 1757, come rilevasi da iscrizione nel Coro mediano, a dritta.
Ma sorpassando questo argomento,
la mistica costituzione di questa Chiesa era d'altronde nei primi tempi
composta di quattro Canonici, e d'un quinto Canonico-parroco, col titolo
di Preposito, che formavano un sol corpo denominato Capitolo Collegiale,
obbligati si gli uni, che l'atro alla officiatura del Tempio ed alla cura
delle anime. In seguito poi li quattro Canonici erano obbligati alla sola
officiatura, ed il Preposito incaricato delle sacre funzioni, delle pubbliche
preghiere, e delle cure delle anime, che doveva far inoltre amministrare
a sue spese da quattro Curati, tra' quali uno illirico a comodo degli Slavi,
che numerosi sempre furono in questa Città; insigniti tanto i Canonici
che il Preposito di fiocco al cappello, calze, collarino a fascia, tutto
di color pavonazzo, zanfarda, cotta colle maniche ossia rocchetto ed anello;
ed in aggiunta in oggi, siccome da lungo tempo avevano dismesso le maniche
della cotta, sono insigniti di rocchetto, mozzetta violacea e croce stellata
dorata con occhiello e nastro rosso, per Bolla dell'attuale Pontefice Pio
IX, 1 settembre 1853.
Del resto la popolazione
di anno in anno cresciuta, onde fosse sopperito ai sorvenuti bisogni spirituali,
ottenne finalmente dal Principe di Venezia in Pregadi
li 23 novembre 1782, che fossero smembrati i quattro in otto Canonicati,
e conservato intatto quello annesso alla Prepositura pel mantenimento dei
quattro Curati; il che fu canonicamente eseguito per Patente del Diocesano
Monsignor Polesini, 1 marzo 1783, aggiungendo ai quattro nuovi Canonici
ed agli otto in avvenire, la cura delle anime. Il quale smembramento fu
mantenuto sino l'anno 1843, in cui il capitolo ottenne un nuovo Statuto,
formulato dal defunto Monsignor Peteani e confermato dal Governo, in seguito
all'organamento della Diocesi, ordinato dalla Sovrana Autorità l'anno
1840; in forza del quale gli otto Canonici furono ridotti a sei, con l'obbligo
costante della cura delle anime.
Una volta questo Capitolo
percepiva la decima delle biade, degli agnelli ed uve, assegnatagli spontaneamente
dal Comune l'anno 1431, onde potessero i Canonici ed il Preposito covenientemente
vivere; la quale cessò sotto il dominio francese l'anno 1810 in
forza dell'attivata imposta prediale, ritraendone invece
fin d'allora quale compenso uno stabile emolumento dal pubblico Erario.
Ora però per lo citato nuovo Statuto e questo emolumento e tutti
gli altri proventi del Capitolo, compresi quelli dei funerali, sono accumunati
e divisibili in quindici parti, due cioè a ciascuno dei sei Canonici
e tre al Preposito, cui sono riservati i proventi di stola bianca ed i
diritti di Offizio Parrocchiale, stipendiando eziando in comune i Canonici
ed il Preposito per loro ajuto nella cura delle anime i quattro Curati
in modo, che anche oggi sono assistiti gli Slavi da uno di loro idioma.
La popolazione di Rovigno
è numerosa, e quindi grave è la cura, che variò da
oltre novemila a meglio che undicimila anime dal 1804 al 1847; ora però
conta Rovigno poco più di diecimila abitanti; decrescimento questo
in forza delle continue emigrazioni.
Oltre i suddetti Canonici
evvi eziando il Canonicato Angelini, istituito dalla contessa Elisabetta
Angelini-Califfi l'anno 1725, a benefizio dei sacerdoti Angelini e di quelli
discendenti da femmine della stessa famiglia, coi medesimi obblighi degli
altri Canonici, meno la cura delle anime, ma col dovere della Mesa quotidiana
all'altar privilegiato di S. Eufemia. Ora da varii anni vacante e scemo
del primitivo patrimonio, viene secondo lo Statuto del 1843 amministrato
gratuitamente dal Capitolo in modo, che sperasi non tardi vederlo ripristinato.
Aveva questo Capitolo anticamente
il gius patronato della Chiesa, Convento e sue pertinenze, sull'isola di
S. Catterina, che supponesi cessato quando, chiamati da questo Comune,
vennero ad abitarla i Serviti l'anno 1486. Però conserva il gius
eligendi del Parroco di S. Antonio Abbate della Villa di Rovigno, abitata
da Morlacchi, e le primizie degli agnelli di quella. Aveva inoltre il patronato
in unione al Comune, il quale in segno di compradonanza pose l'anno 1732
il proprio Stemma su la porta laterale, di questa insigne Collegiata,
sotto la special protezione al tempo veneto del Consiglio di X, ed ora
dell'Imperial Governo, che ne esercita il dominio vogtetico.
In fine questa chiesa ha
un sufficiente patrimonio in capitali fruttanti, oltre a ricco addobbo,
come fu detto, di paramenti e di suppellettili: ma venne sempre decorosamente
mantenuta in ispecialità colle generose limosine dei cittadini;
amministrato il tutto e tenuto in con in ogni tempo da interessare e zelanti
questure.
Da questi pochi cenni ed
imperfetti traspariscono, come sotto a velo un bel volto gentile, i pregi,
le condizioni e i titoli onorevoli ed illustri di questa Chiesa, non immeritovole
per certo che sovra d'essa posi lo sguardo amorevole del nuovo Prelato,
e che l'ami anch'Egli, considerandola quale infatti fu sempre, la più
bella e cara gemma dopo la Cattedrale del Parentino Episcopato.
ANTONIO ANGELINI
FU STEFANO
|