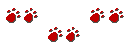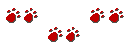Io avevo un cane
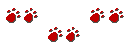
A volte penso che sia grazie a quel cane se ora io sono qui. Perché quel
cane non era solo un cane era anche una goccia.
E quel cane che era una goccia ha fatto traboccare un vaso, e il vaso
era la mia vita.
Dunque penso che sia merito suo, a quel cane senza un vero nome.
Non ne ho mai scritto. Una volta, quando avevo 16 anni scrissi una
poesia per lui, subito dopo il fatto. Da allora non ne ho più scritto, e
ne ho parlato anche poco. Quando l'ho fatto, l'ho fatto nel modo che si
usa tra persone cresciute, e ogni volta ho scoperto che non ero affatto
cresciuta in quello specifico caso, e così semplicemente, come fanno le
persone cresciute, l'ho rimosso.
E' colpa dell'NG se ora ne scrivo, seriamente, per la prima volta.
E mi sa che sarà una roba lunga, perché c'ho dentro un po' di rospi che
somigliano tanto a dei Velociraptor, una cassa di birra, e un bel po' di
sigarette.
LA NASCITA
Dunque, avevo un cane senza nome, questo l'ho già detto.
Di nomi in realtà ne ha avuti anche troppi, e questo secondo me non è
mai un buon segno, l'indecisione su certe cose è significativa.
Arrivò a casa dei miei, che allora era casa anche mia, la notte
dell'ultimo dell'anno dell'89, tra le mani di un contadino.
Il contadino era un conoscente di famiglia, perché viveva nella nostra
casa di campagna e amministrava la nostra terra lì attorno.
Il cane aveva poche ore di vita, sembrava un topo, a detta di mia madre,
che aprì la porta quella sera e lo lasciò entrare.
Il contadino non era solo un contadino, era anche un uomo stupido.
A casa sua, come in qualsiasi altra casa che avesse lo stesso fuso
orario, si faceva festa. Tavolate imbandite, figli, nipoti, parenti,
roba così. Questa gente non pensò alla cagna incinta che dormiva
sull'aia. Alla loro cagna incinta. Cominciarono a darci sotto con i
mortaretti, finché quella povera bestia non partorì e scappò per i
campi, terrorizzata, abbandonando i suoi cuccioli appena nati.
Era gente stupida, l'ho già detto.
Quattro cuccioli, tutti uguali, neri come la madre.
Quando il contadino e la sua famiglia si accorsero di quello che era
successo, la loro cagna era scappata già da un bel po', e tre dei
cuccioli erano morti. Uno era vivo. Il mio cane.
Lo portarono da noi, perché avevano dato per scontato che la madre fosse
morta, e a loro serviva un nuovo cane da guardia.
Dovevamo tenerlo solo per un po', poi se ne sarebbero occupati loro.
Solo un po' di tempo.
Non ho avuto nemmeno la soddisfazione di poter guardare in faccia quel
contadino stupido, di guardarlo in maniera sprezzante - che è il mio
cavallo di battaglia da anni - perché in quel momento ero probabilmente
collassata nel soggiorno di qualcuno.
LA CONVIVENZA
Solo alle otto del mattino seguente, nell'entrare in casa, e più
precisamente in cucina, capii che avevo un nuovo cane (Fuffi, il mio
cane-salsiccia, era morto nell'estate dell'88, dopo una gloriosa - in
tutti i sensi - vita di 12 anni).
C'era una scatola piena di stracci in cucina e quella scatola guaiva.
La scatola, gli stracci, e i guaiti vennero immediatamente trasportati
in camera mia, e lì restarono, fino al giorno in cui me li strapparono
con la forza, dalle mani.
C'era sul mobile del soggiorno una giornale di due giorni prima, sulla
prima pagina c'era Gorbaciov che parlava di Perestrojka, guardai i
guaiti dritti negli occhi e decisi di chiamarli Gorbie, il suo primo
nome.
Quello che successe dopo, fu una sedicenne e un cane piccolissimo che
avevano deciso che sì, insieme la vita pareva proprio niente male.
La sedicenne nei primi tempi gli dava da mangiare con un biberon, il
cane dormiva sulla sua mano, il cane piangeva se lei non restava lì con
lui, ma il cane non piangeva quasi mai perché era difficile non
trovargli la sedicenne appiccicata.
Così andò per un po' di tempo.
Una mattina la sedicenne si svegliò molto presto, perché forse aveva
sentito un rumore, e si trovò il suo cane addormentato al suo fianco,
ormai era un cucciolo dalle zampotte grosse, e lei pensò che presto
sarebbe diventato grande e forte, e poi pensò che era bellissimo.
E si stupì di quanto fosse facile e naturale amarlo più di ogni altra
cosa.
Così andò per un po' di tempo.
PRIMI PROBLEMI
La madre del mio cane non era morta.
Era fuggita nei campi e per più di un mese era restata là, a
sopravvivere.
Nessuno sa cosa o come avesse fatto per restare viva, quando ritornò era
conciata da paura, ma stava ritta sulle zampe.
Non si fidò mai più dei suoi padroni, e il suo carattere cambiò molto,
anche se restò docile e servizievole.
Si vedeva però che aveva uno sguardo diverso, e non amava più giocare
con tutti come una volta.
Tornò al suo posto, sull'aia, a fare la guardia alla casa e a correre
dietro alle galline, per quanto la catena glielo permettesse.
Il contadino non aveva più bisogno del mio cane.
I miei genitori non ne avevano mai avuto bisogno.
Solo a me importava.
E io non valevo molto.
Mio padre, quando si faceva vedere in casa, continuava stupidamente a
chiamarlo Gringo.
Gli avevo ripetuto un milione di volte che il suo nome era Gorbie, che
io l'avevo chiamato così, e che lui si era sentito chiamare così dal
giorno che era nato.
Era stupido chiamarlo con un altro nome, lo confondeva e basta, ed era
ancora più stupida la noncuranza con cui lo faceva mio padre, lo
chiamava così perché gli andava, se ne fregava del cane, e se ne fregava
anche di me. La ragazzina invisibile con il cane invisibile.
Mia madre lo chiamava Mìmi, che non è un vero e proprio nome, è un
vezzeggiativo anconetano che si usa con i bambini piccoli e con le
creaturine in generale. Non voglio neppure cominciare ad indagare su
come mia madre abbia potuto permettere quel che poi è successo.
Non l'ho mai fatto e non lo farò neanche ora, ci sono certe cose nella
vita di una persona che non possono essere comprese o giustificate, ma
solo giudicate, anche se è sbagliato.
Comunque alla fine cedetti sul nome Gorbie, nessuno lo chiamava così,
il cane si sentiva chiamare in duecento modi diversi, e questo non gli
faceva certo bene. Presi a chiamarlo Mìmi anch'io, per non confondergli
troppo le idee.
Continuava a dormire con me nel mio letto, lo facevo giocare con le
pallette di gomma e mi occupavo io del suo nutrimento e dei suoi
bisogni.
Il cane cresceva, e anch'io.
I PROBLEMI PEGGIORANO
Nessuno me lo disse apertamente ma non lo fecero per delicatezza.
Semplicemente quello che pensavo io non contava niente, e quindi era
inutile che ne parlassero con me. Anzi che ne parlasse con me, perché la
decisione fu di mio padre e ne parlò a malapena con mia madre.
Un giorno a tavola, all'ora di pranzo, aprì bocca e disse con tutta la
naturalezza di questo mondo che il cane non poteva restare, e che era
una bella rogna perché ormai il contadino non lo voleva più.
Lo disse così, tra una forchettata e l'altra.
Io non sono mai stata una persona docile, ma ho una diplomazia innata
che tante volte mi ha salvato il culo. E' una dote utile perché ottengo
quello che voglio senza fare troppo casino. Io i muri non li ho mai
buttati giù a cornate, io coi muri ci parlo finché non si sbriciolano.
Ma con mio padre è sempre stato inutile parlare e così posai la
forchetta e dissi "il cane resta" guardandolo dritto negli occhi. Poi
ripresi la forchetta e continuai a mangiare. Pensai che dovevo
continuare a mangiare, anche se avevo la nausea e tremavo come una
foglia, perché avevo appena dato un ordine a un mio diretto superiore e
questo si chiama ammutinamento, sissignore, e che io sapessi, nessun
capo di una rivolta, nei secoli dei secoli, era corso al cesso a
vomitare subito dopo aver dichiarato le sue intenzioni.
Era un ammutinamento e mio padre lo prese come un ammutinamento.
Cominciò a dirmi che ero una cretina e che me le avrebbe date, lo disse
gridando e io non alzai lo sguardo dal piatto e continuai a mangiare in
silenzio, rigida sulla sedia per tutto il tempo.
Sentivo che stavo per piangere dalla rabbia e allora mangiavo.
Mio padre concluse il suo discorso chiedendomi se avevo capito bene, se
era tutto CHIARO, e io - che non avevo sentito una sola parola di quello
che aveva detto - non gli risposi, non alzai la testa, come se la sua
faccia, le sua urla, i suoi occhi non fossero lì, a un metro da me.
Lui si alzò di scatto da tavola e disse a mia madre che aveva una figlia
deficiente, poi andò in terrazza a fumare.
Desiderai che morisse e immediatamente ebbi orrore di me stessa per quel
desiderio, non trovai soluzione migliore che correre in camera a
piangere.
APOTEOSI DEL PROBLEMA
Ero piccola, anche se avevo già sedici anni.
Forse in molte cose sembravo più grande, e in alcune me la cavavo
abbastanza, ma in certe cose avevo proprio sedici anni, e per quel tipo
di cose sedici anni sono troppo pochi.
Per quello che potevo mi ero documentata: sapevo già che non bastava
voler bene a un animale per farlo crescere bene, servivano anche cose
più prosaiche, ma infinitamente necessarie come la giusta alimentazione,
un adeguato esercizio fisico, un veterinario fidato.
Fuffi il cane salsiccia era entrato in casa mia quando io avevo quattro
anni, e per forza di cose non ero stata io ad allevarlo. Anche dopo,
quando ero già grande, fu sempre mia madre ad occuparsi materialmente di
lui.
Ora non potevo contare su nessuno, e quindi toccava a me crescere il mio
cane. La cosa non mi dispiaceva affatto, e non mi pesava. Credo che
segretamente avessi la speranza di dimostrare una completa
responsabilità su di lui, e che di conseguenza non si sentissero negli
impicci più di tanto, e mi lasciassero in pace.
Comprai un libro sui cani, e scoprii che Mìmi aveva molte
caratteristiche del cane da caccia, anche se ovviamente era un
bastardino.
Di certo sarebbe diventato un cane grande almeno quanto la madre, e la
madre aveva più o meno le dimensioni di un setter.
Ormai era Marzo e Mìmi mi arrivava già a metà coscia.
Lo portavo a passeggio e gli avevo insegnato ad obbedire ai comandi più
elementari come "Alt" e "seduto", era un cane intelligente e sensibile,
non faticai molto ad educarlo.
Mi seguiva ovunque.
A casa, scoprii che il mio ammutinamento stava dando buoni frutti: mio
padre se ne stava buono già da un po', e io mi sentivo quasi in salvo.
Ovviamente non era così.
Dopo un po' l'argomento tornò alla ribalta, ma non fu lui a parlarmene,
fu mia madre. Il portavoce storico.
Mia madre mi disse che non potevamo tenere il cane.
Cercò di dirmelo nel migliore dei modi, ma non c'era un modo migliore
per dirmi una cosa così.
Mi disse che il cane sarebbe diventato troppo grande e che non potevamo
tenerlo in quella casa.
Mi disse che saremmo andati incontro a dei problemi con i vicini per
colpa sua, perché era troppo vivace per vivere in una casa come la
nostra.
Alle mie orecchie tutte queste buone ragioni suonavano come una raffica
di cazzate, e a dire la verità, anche a distanza di dieci anni
continuano a suonarmi così.
La casa non è mai stata tanto piccola da non poter ospitare un cane di
taglia medio-grande, e visto che è sempre stata nostra i vicini potevano
anche andare a farsi fottere da uno stercoraro.
Questo grosso modo quello che risposi alle sue osservazioni, e questo
grosso modo è quel che le risponderei tuttora.
Lei tornava sempre più spesso sull'argomento e io ogni volta le dicevo
che doveva smettere di parlarne, perché tanto il cane restava.
Questo tira-e-molla durò quasi due settimane, finché un giorno mio padre
mi disse che ora si era davvero seccato e io gli risposi che per me
poteva seccarsi fino a disidratarsi, ma questa volta l'ammutinamento non
funzionò.
Scoprii quel giorno che non ci si può ammutinare più di una volta contro
la stessa istituzione, e che un solo ammutinamento fatto da una
sedicenne non basta.
Lui questa volta non gridò, ma mi disse che non potevo impedirgli in
nessun modo di portare via il cane, perché quella era casa sua, e finché
abitavo sotto il suo tetto e dipendevo da lui, io avrei fatto quello che
lui diceva. E lui avrebbe portato via il cane.
Così gli risposi, e questa volta gridavo io, che col cazzo avrebbe
portato via il cane, non finché fossi restata in quella casa.
E lui rispose che allora lo avrebbe fatto di mattina presto, quando ero
a scuola.
Il cane dormiva di là, mentre io dissi a mio padre che lo odiavo e lo
avrei odiato per sempre.
IN CERCA DI UNA CASA
Non mentii. Mi presi l'ultimo ceffone della mia vita per aver detto la
verità. Mio padre non deve avermi dato più di cinque schiaffi da quando
sono nata, e quello fu l'ultimo.
Probabilmente me lo diede non perché gli avevo detto che lo odiavo, ma
perché si vedeva che era vero, e una cosa così detta da un figlio non
può considerarsi un successo.
Non mi pento di averglielo detto. Mi riprenderei quello schiaffo
un'altra volta preciso identico. L'odio che provai per lui in quel
periodo era sacrosanto e se lo meritava tutto.
E' mio padre e gli voglio bene, ma quando ripenso a lui che mi dice che
mi avrebbe portato via il cane quando ero a scuola io lo odio ancora,
sì, credo che per quella cosa lo odierò anche dopo che sarà morto.
Sapevo che non c'erano più speranze di tenere Mìmi con me.
Piansi, minacciai e supplicai, finché mi resi conto che qualsiasi cosa
avessi fatto sarebbe stata del tutto inutile.
Capirlo e sentire il mio cuore che andava in pezzi fu un tutt'uno.
Dovevo trovargli una nuova casa, un buon posto dove vivere, se dovevo
transigere sulla mia felicità assolutamente non volevo farlo con la sua.
I miei volevano portarlo dal contadino stupido, nella capanna che mio
padre si era costruito vicino alla casa, dove teneva un orticello che
curava di persona, giornalmente, appena staccava dal lavoro.
Per me era inaccettabile. Quell'uomo aveva già nuociuto alla madre del
mio cane, ed era ovvio che avrebbe fatto lo stesso con lui. Di mio padre
mi fidavo meno che del contadino stupido.
Non sprecai fiato in opposizioni e lo impiegai per mettere annunci sul
giornale, per la strada, negli ambulatori veterinari. Sparsi la voce
prima tra i miei amici, poi tra i conoscenti, alla fine a chiunque
incontrassi.
Passavo i pomeriggi ad attaccare volantini e ad aggiornare gli annunci
sul giornale, utilizzavo i pochi soldi che avevo in tasca per farlo.
Per ironia della sorte nessuno voleva il mio cane, e io che avrei dato
tutto per tenerlo non potevo.
Fu una settimana orribile. La mattina andavo a scuola e uscivo alle due,
ogni giorno tornavo a casa con il terrore che mio padre avesse messo in
pratica quello che mi aveva minacciato. Il pomeriggio portavo Mìmi con
me e cercavo disperatamente di trovargli dei padroni. Tornavo a casa
all'ora di cena e cenavo in camera mia, perché non sopportavo di
dividere il pane con i miei genitori. Ormai non parlavo più con nessuno
dei due. Mia madre era molto triste per questo ma io me ne fregavo, se
soffriva le stava bene.
La sera mi coricavo presto perché ero distrutta, e fantasticavo di
andarmene via di lì con il mio cane, di scappare, in pratica non avrei
saputo dove andare perché ero senza soldi ed ero piccola, mi sentivo
impotente, e avevo paura. Così ribattevo la faccia nella realtà e
abbracciavo Mìmi più che potevo, e ogni volta pensavo che presto non
avrei più potuto abbracciarlo prima di dormire, così gli piangevo
addosso e lo stringevo, finché non mi addormentavo.
LA PARTENZA
Non mi ricordo il giorno preciso in cui Mimì abbandonò la mia casa.
Credo di aver rimosso un sacco di particolari, perché a volte quello è
l'unico modo per continuare a campare dignitosamente.
Ricordo vagamente di essere salita sulla macchina di mio padre, e di
averlo accompagnato fino alla fottuta casa di campagna.
Non ricordo il viaggio di ritorno.
Una volta lessi una frase in un fumetto di Peanuts: Lucy stava tentando
in tutti i modi di buttare fuori di casa suo fratello Linus, e proprio
quando c'era riuscita sua madre aveva partorito un nuovo fratellino.
Esasperata Lucy commentava la faccenda dicendo che non si poteva spalare
l'acqua con un forcone.
Nelle settimane precedenti alla partenza del mio cane a me era sembrato
di spalare continuamente acqua con un forcone.
Per quanti sforzi facessi la situazione non cambiava, fino al giorno in
cui non ci fu più niente da fare.
Nessuno aveva voluto il mio cane, e il cane non poteva più restare.
Ero diventata una schiacciasassi, come solo una sedicenne può diventare:
litigavo furiosamente con tutti quelli che tentavano di convincermi che
quella era l'unica soluzione, non avevo più paura delle minacce e degli
insulti di mio padre, perché semplicemente niente sarebbe stato peggio
che vedere andar via il mio cane.
Eppure mi toccò vederlo.
Venne portato nel posto in cui era nato, poche decine di metri più in
là, nella capanna di mio padre.
Lui pensava si trattasse di una gita e correva tutto contento dietro
alle galline.
L'ultima cosa che ricordo di quella giornata sono i suoi occhi mentre mi
vedeva andare via in macchina. Il contadino lo tratteneva per il collare
e io lo vedevo rimpicciolirsi dal finestrino sul retro.
Anche quando non riuscii più a scorgere chiaramente la sagoma continuai
a sentire i latrati per un bel po'.
Io ero crollata sul sedile di dietro a sperimentare una nuova gamma di
brutte sensazioni, molte delle quali sconosciute, e mi sentivo
febbricitante e debole. Mi sentivo malata. Nelle ossa.
Malata di una malattia che ti fa marcire dal di dentro ma che ti lascia
viva, così mi sentivo.
Era un dolore fisico, nelle ossa.
Misero una catena al collo del mio cane, che fino ad allora non ne aveva
nemmeno mai vista una. Fu costretto a dormire in terra, chiuso nella
capanna, da solo, dopo aver passato tutta la sua vita, fino a quel
giorno, a dormire in un letto con me vicina.
Non voglio immaginare quello che deve aver provato quella prima notte,
quanto deve aver pianto e guaito senza capire perché non c'ero più,
perché l'avevo lasciato solo.
Quel pianto io non l'ho mai sentito ma è lo stesso nel mio cervello, e
non credo che se ne andrà tanto facilmente.
Come Clarisse nel Silenzio degli innocenti, anch'io ho un innocente che
grida nella mia testa, e non ho nessun serial killer da fermare per
farlo smettere.
QUEL CHE SUCCESSE DOPO
Lo andavo a trovare tutti i pomeriggi. Prendevo l'autobus all'andata e
certe volte andavo direttamente lì da scuola, senza passare da casa.
Ogni pomeriggio gridavo contro mio padre e il contadino perché non
accettavo che il mio cane fosse legato ad una catena. Loro non dicevano
niente, mi assecondavano come si fa con una pazza, tacevano finché non
smettevo di maledirli.
Scioglievo il mio cane e ci giocavo insieme finché era buio, poi
percorrevo i soliti venti minuti di auto con mio padre per tornare a
casa. Sedevo sempre nel sedile di dietro perché non sopportavo l'idea di
avere mio padre tanto vicino.
Credo che non volessi stargli vicino perché avevo paura che se me lo
fossi trovato a tiro avrei potuto fargli qualcosa.
Sentivo che avrei potuto farlo.
Sentivo che avrei voluto.
In quei tragitti in macchina, dove il silenzio era tanto fisico che
aveva anche un odore, avvertivo che il confine che esiste fra il
desiderare una cosa e farla era troppo sottile.
Vidi il mio cane impazzire, di giorno in giorno.
Non si abituò mai alla sua nuova vita, e impazzì.
Non potevo stare tutto il giorno con lui, e non sapevo cosa succedeva
quando io non ero lì. Avevo dei sospetti, e anche se erano dei sospetti
li trasformavo in accuse, tanto per essere sicura.
Il contadino aveva paura di me: una volta trovai una ferita sul corpo di
Mìmi, alla base del collo. Era una ferita non grande ma piuttosto
profonda. Non poteva essersela fatta da solo. Dissi al contadino che non
mi importava di sapere cosa gli aveva fatto, ma che se risuccedeva io
avrei fatto la stessa cosa a lui.
Seppi poi da mia madre che il contadino parlò con mio padre quella sera,
e gli disse che ero una ragazzina cattiva, e che non c'era da
meravigliarsi che il cane si lasciasse avvicinare solo da me, perché ero
cattiva quanto lui. Mio padre non fece parola con me di questo episodio,
probabilmente pensava la stessa cosa, ma ero pur sempre sua figlia.
Il contadino aveva paura di me almeno quanto aveva paura del cane.
Mìmi dopo un mese di quella vita era molto cambiato. Abbaiava
furiosamente e digrignava i denti se qualcuno tentava di avvicinarglisi,
lo faceva con tutti, tranne che con me.
Con me era lo stesso cane di sempre. Giocavamo per delle ore insieme,
gli portavo la pappa e lui cominciava a fare le feste non appena sentiva
i miei passi sullo sterrato, e cioè almeno cinque minuti prima che
arrivassi.
Spesso quando mi sedevo sull'erba mi si accovacciava sulle gambe e mi
metteva il muso in grembo, come faceva quando era piccolo. Ormai era un
cane piuttosto grande e non riusciva mai del tutto ad accovacciarmisi
sopra senza far spuntare una zampa. Spesso restava lì e si addormentava.
A volte mi addormentavo anch'io.
Non so da dove mi arrivi questa certezza, ma credo che Mìmi non avesse
mai sonno quando si addormentava, in pieno pomeriggio, sulle mie gambe.
Credo che lo facesse per avere un sonno tranquillo, e per dimenticare la
paura.
Sentivo la sua paura, era sconfinata.
Aveva paura dal momento in cui apriva gli occhi al mattino finché non
tornava a chiuderli la sera. Gli animali hanno modi misteriosi per
comunicarti le cose, ma sempre inconfutabili.
La sua vita era cambiata troppo, e troppo in fretta. Non era una cosa
difficile da capire.
Era un animale sensibile e intelligente, e queste due cose l'hanno
fregato, proprio come succede alle persone. Fosse stato più stupido
probabilmente ce l'avrebbe fatta.
Di giorno in giorno, non potevo fare a meno di vedere l'atteggiamento
che riservava agli altri: era evidente che se qualcuno si fosse
avvicinato più del dovuto lui l'avrebbe morso.
Così passava le giornate solo finché non arrivavo io, e più restava solo
più aumentava la sua paura.
Io cercai di parlare con mia madre, di dirle che Mìmi stava impazzendo,
e che doveva tornare subito a casa nostra. Prese questa cosa come
l'ultimo tentativo di una ragazzina che cerca di spuntarla.
Allora un pomeriggio la portai con me, e così vide Mìmi ringhiarle
contro e mostrarle i denti, con gli occhi pazzi.
Mia madre non è mai stata stupida, non lo è adesso e non lo era nemmeno
allora, rimase male per quel che vide e seppe che avevo ragione, non
pensò che Mìmi fosse un cane cattivo, pensò che era un cane
terrorizzato, e sapeva che l'unica cosa giusta da fare sarebbe stata
farlo tornare con noi.
Penso che per un secondo sia stata lì-lì per farlo.
Mia madre non è mai stata stupida, ma è una di quelle donne che nascono
con l'idea della missione a tutti i costi. Lei trova sempre una missione
da compiere, e deve compierla fino in fondo, anche se le fa schifo.
Ha
sopportato sua suocera per quarant'anni passando sopra ad accuse,
cattiverie e umiliazioni, fino al giorno in cui quella donna infernale
non si è decisa a tirare le cuoia, e lo ha fatto perché aveva dato la
sua parola di farlo. Non esiste il patteggiamento per mia madre. Non
esiste la diserzione intelligente.
Mia madre non è stupida, ma certe volte riesce quasi a farti dimenticare
che non lo è.
Riportare a casa il cane significava andare contro le decisioni di suo
marito. E questo entrava in conflitto con la sua missione principale, e
cioè amarlo e rispettarlo finché morte non li avrebbe separati. Visto
che la prima cosa era stata accantonata già da tempo era fermamente
convinta nell'essere ligia almeno nella seconda.
Ha cercato di inculcare lo stesso senso del rispetto a priori verso di
lui anche a me e mia sorella, ripetendoci fino alla nausea che lui era
nostro padre, che ci manteneva nella sua casa e non ci faceva mancare
niente, per questo meritava rispetto e l'ultima parola sulle decisioni
importanti.
La realtà delle nostre vite era in evidente contraddizione con quello
che lei diceva, mia sorella all'epoca aveva già 28 anni e io 16, nessuna
delle due era più una bambina. E anch'io, che ero molto più piccola,
ormai avevo capito come funzionavano le cose a casa nostra. Nostro padre
non passava né aveva mai passato tempo con noi, non si era mai curato di
parlarci, di ascoltarci, di aiutarci se ne avevamo la necessità. Mia
madre ci aveva cresciute praticamente da sola, e da sola si occupava
della casa e delle nostre vite. Mio padre lasciava che fosse mia madre a
sbrigare la maggior parte delle cose, e in linea di massima si
disinteressava completamente della sua famiglia. L'unica cosa vera era
che ci manteneva, e materialmente non ci mancava nulla.
Ha sempre tenuto una vita da single pur possedendo una famiglia.
Aveva il suo lavoro e il suo orto da accudire e così passava gran parte
della giornata fuori casa, quando c'era non parlava mai con me e se lo
faceva era per rimproverarmi o vietarmi qualcosa, spesso per dimostrare
semplicemente che esisteva ancora o per esercitare il suo diritto al
comando.
Senza dubbio ci amava, a modo suo, e credo che ci ami ancora. Ma non ci
ha mai amato abbastanza da rinunciare al suo ermetismo e ai suoi
interessi. Siamo sempre stati secondi per lui. E mia madre che l'ha
sempre saputo - anche se all'epoca non l'avrebbe ammesso nemmeno sotto
ipnosi - negava l'evidenza e si comportava come se fossimo una
famigliola felice, si sforzava di tenere in piedi quella menzogna perché
quella menzogna era l'unica cosa che contasse, sembrare una famiglia
felice se proprio non riuscivamo ad esserlo: la missione di tutte le
missioni.
E così se mio padre si pronunciava su qualcosa quella era legge.
Mio padre non si pronunciava quasi mai, e mia madre pensava che fosse
giusto premiare quel sovrumano sforzo con l'accondiscendenza
incondizionata, quando capitava.
Mio padre si era pronunciato molto chiaramente nei riguardi del cane,
lei era l'unica che avrebbe potuto contrastarlo, ma mia madre non lo
contrastò per non dispiacerlo.
Fu così che condannò a morte il mio cane.
QUEL CHE FECE IL CANE
Erano passati due mesi da quando il mio cane mi era stato portato via,
era Giugno.
La scuola stava per finire, e io quell'anno ne ero particolarmente
felice perché avrei potuto passare più tempo con Mìmi.
Ormai da qualche settimana covavo un pensiero segreto: ero più che
decisa a toglierlo da lì e riportarlo a casa. Senza la scuola tra i
piedi avrei potuto badare a lui continuamente, e cercare di riparare ai
danni che quella permanenza traumatica gli aveva causato.
L'avrei riportato a casa, e nessuno avrebbe potuto impedirmelo perché
ero pronta a tutto. Erano passati solo due mesi da che Mìmi era lì,
ormai era considerato da tutti un mostro.
E in un certo senso ero diventata un mostro anch'io.
Non ero più spensierata come prima e mi sentivo invecchiata di
cent'anni, ero infelice e sentivo che un bel po' di cose, che prima
erano dentro di me, si erano rotte per sempre. Al loro posto era
arrivata una sicurezza gelida e crudele, che mi faceva paura e faceva
paura a mia madre.
Ero cresciuta.
L'avrei riportato a casa, e avevo già pronti gli espedienti più meschini
e biechi per tenercelo.
Non avevo più paura di mio padre, se mai aveva avuto un ascendente su di
me, dopo aver visto gli occhi della creatura che amavo di più al mondo
cambiare dalla felicità alla pazzia, l'aveva perso completamente.
Era come se all'improvviso il punto di vista da cui lo osservavo fosse
cambiato, come se avessi subìto una velocissima zoomata all'indietro e
lui ne fosse uscito completamente ridimensionato.
In parole povere mio padre era diventato uno stronzo qualsiasi, uno di
quelli che quando sei nella merda se ne frega, uno che non fa nessuno
sforzo per cercare di capirti, un egoista cosmico che pensa solo ai
cazzi suoi anche se è la figlia a stare male.
In quei due mesi avevo realizzato che lui non mi avrebbe mai protetto se
ne avessi avuto il bisogno, e che dunque avrei dovuto sempre cavarmela
da sola nella vita.
E' un uomo qualsiasi, mi dissi, e nemmeno della miglior specie.
Posso tenergli testa ormai.
Successe qualcosa prima che potessi attuare il piano.
Il mio cane ormai era pazzo, dentro di me io lo sapevo, anche se non lo
ammettevo.
Mi dicevo che ci sarebbe voluta molta pazienza e fatica, ma sarebbe
tornato sano e felice una volta lontano da lì.
Probabilmente invece ormai era troppo tardi.
Sapevo anche questo. Era un informazione sepolta nella mia coscienza che
non volevo accettare, ma lo sapevo.
Io continuavo ad essere l'unica persona che lo poteva avvicinare, la
novità era che per due volte era riuscito a rompere la catena. La prima
volta aveva tentato di aggredire la moglie del contadino e la seconda il
contadino stesso. Non ci era riuscito per pura fortuna. Però era
riuscito ad arrivare all'altro cane (che poi era sua madre) e a morderlo
gravemente.
Dopo questi exploit Mìmi era stato rinchiuso in uno sgabuzzino semibuio
che dava sull'aia, incatenato e con la porta sprangata.
Quando arrivavo, lo liberavo e lo portavo a passeggiare, ma al
guinzaglio, perché ormai era effettivamente pericoloso per gli altri
lasciarlo sciolto, e prima di aprire la porta dello sgabuzzino dovevo
parlargli a lungo per farmi riconoscere.
Appena capiva chi ero si calmava immediatamente, ma conservava nello
sguardo un qualcosa di malato che non se ne andava mai del tutto.
Certe volte non riuscivo a guardarlo senza mettermi a piangere, era come
assistere giorno per giorno all'agonia di una persona amata, agli
sgoccioli della sua malattia terminale.
Alla fine della giornata, in certi giorni benedetti, sembrava essere
quello di un tempo, quello sguardo se ne andava per un po', e quello era
il mio unico appiglio per credere ancora che potevo salvarlo.
Gli ripetevo continuamente "ti porto via, ti porto via. Un po' di giorni
ancora, una settimana, e ti porto via".
La campagna era al massimo splendore e spesso la mia famiglia al
completo si trasferiva lì nel pomeriggio, e per la cena.
A volte avevamo ospiti e io odiavo tutti loro quanti erano, con i loro
sorrisi stupidi e i loro vestiti estivi, a mangiare e ridere e scherzare
a pochi metri dal mio cane malato.
Era colpa loro se ora lui stava così e non se ne curavano affatto,
dicevano "così è la vita" come se fosse stato uno scherzo della sfortuna
a ridurlo in quel modo.
Li odiavo, e si vedeva.
Mia madre in quei mesi aveva tentato in tutti i modi di ristabilire un
contatto con me, ma da me aveva solo ricevuto veleno.
Una volta mi si mise a piangere davanti e ne fui terrorizzata, la vedevo
piangere e intanto sentivo tutto un mondo di piccole certezze che si
sbriciolavano e scivolavano via con le sue lacrime.
Anche se ero furiosa con lei, lei era tutto quel che mi rimaneva della
mia famiglia, lei era sempre stata il punto di riferimento, la
roccaforte, il bastione. Era lei la persona importante.
Oltre quello c'era il mondo vero e io ne avevo paura, ci camminavo in
mezzo, ma come tutti gli adolescenti ogni tanto mi voltavo per vedere se
lei era ancora lì, a proteggermi.
Avevo bisogno di mia madre, non poteva crollarmi davanti così.
Ero sconvolta.
Successe di mattina, io ero a scuola, uno degli ultimi giorni.
Nessuno mi ha spiegato mai per bene quel che successe.
L'unica cosa che so, è che venne il figlio del contadino a trovare i
genitori.
Aveva portato con lui, oltre alla moglie, anche i due figli: un
ragazzino di circa di dieci anni e un bimbo di tre.
Il bimbo di tre deve essere rimasto attaccato alla la madre per tutto il
tempo della visita, per fortuna, ma quello di dieci no.
Quello di dieci non si sa per quale motivo andò da Mìmi.
Forse la porta non era chiusa bene, fatto sta' che Mìmi gli si avventò
contro, e se non fosse stato legato probabilmente lo avrebbe ucciso.
Se la cavò con un morso al braccio destro e una caviglia slogata.
Il cane nel buttarglisi addosso riuscì a morderlo ma contemporaneamente
lo spinse per terra, fino a farlo uscire dal suo raggio d'azione. Il
ragazzino nel cadere si slogò la caviglia, ma è grazie a quella caduta
se è vivo.
CONSEGUENZE
Il contadino e la sua famiglia odiava il mio cane già da molto tempo,
avevano tentato di cacciarlo quasi subito dopo il suo arrivo, e so per
certo che si lamentavano con mio padre della sua presenza.
Credo che avrebbero tentato di ucciderlo se solo si fosse lasciato
avvicinare, e di certo lo picchiavano quando io non potevo vedere.
Lo odiavano quando non c'era motivo per farlo e ora che aveva morso il
loro nipote il motivo c'era.
Mi dispiacque per quel bambino che non c'entrava nulla, ma tutti loro ne
fecero l'espediente perfetto per sbarazzarsi di Mìmi una volta per
tutte, e irrazionalmente non potei fare a meno di detestarlo.
Ora che aveva una ferita quasi del tutto rimarginata sotto la
fasciatura, e zoppicava solo un po', la sua famiglia aveva smesso di
preoccuparsi per lui e cominciava a vedere i lati positivi della
faccenda.
Noi venimmo informati immediatamente dell'accaduto, e tenuti in costante
aggiornamento finché il bambino non tolse la fascia e ricominciò a
correre senza fatica. Ogni giorno il contadino parlava con mio padre, e
sua moglie teneva mia madre al telefono almeno mezzora tutti i giorni.
L'argomento era sempre quello: via il cane dalla casa. Non potei sentire
le telefonate, ma qualche discorso del contadino a mio padre sì, e vidi
il suo atteggiamento cambiare, dalla vera preoccupazione dell'inizio
fino all'enfasi simulata, quando suo nipote guarì.
Ogni giorno questa sceneggiata, sempre più ricca di dettagli e di
pathos. Per due settimane.
Mia madre non faceva niente, presa com'era ad interpretare Ponzio
Pilato. Mio padre non faceva niente perché l'importante era che il cane
non stesse tra le balle a lui.
La situazione però era tesa in campagna e per quelle due settimane
sembrava di essere a teatro, ognuno a recitare la propria parte.
Ero dietro la capanna di mio padre e facevo il bagno a Mimì. Era sciolto
e si lasciava insaponare docilmente, ogni tanto tentava un accenno di
gioco. Sembrava un uomo invecchiato in prigione che non si ricorda più
come si deve fare per divertirsi.
All'improvviso sentii questa voce. Subito non capii le parole, era una
voce piagnucolante, patetica.
Il contadino.
Per un attimo credetti che stesse parlando da solo. Poi sentii la voce
di mio padre, i monosillabi di mio padre.
Stavano discutendo davanti la capanna a pochi metri da me, un'altra
delle loro inutili discussioni.
E in questa inutile discussione stavano decidendo le sorti del mio cane.
Appresi in questo modo che avevano chiamato un veterinario, e che a
giorni lo avrebbero abbattuto.
QUEL CHE FECI IO
Asciugai il mio cane, lo ricondussi alla sua cuccia. Avrei dovuto
portarlo a passeggio ma lo coccolai un po' e lo chiusi dentro.
Non volevo fosse intorno a me in quel momento. Aveva già avvertito il
mio cambiamento d'umore e aveva cominciato ad agitarsi.
Non volevo fosse lì vicino a me. Avrebbe morso per difendermi e io non
l'avrei fermato.
Piombai di fronte a loro quando ormai parlavano d'altro.
Non fecero in tempo a fare niente.
Acchiappai il contadino per la camicia e con tutte le forze lo spinsi a
terra. Non se l'aspettava. Cadde giù immediatamente.
Né mio padre né lui sapevano cosa fare. Prima che venisse loro in mente
qualcosa cominciai a gridare. A urlare.
Urlavo minacce e insulti e maledizioni a quel contadino steso ai miei
piedi. Non so quanto durò.
Poi mio padre mi prese per un braccio. Probabilmente voleva solo
fermarmi, non strinse, ma io lo colpii lo stesso.
Un manrovescio. Una botta d'avambraccio mentre mi liberavo dalla sua
stretta.
Lo colpii in pieno viso.
Cominciai a dirgli di non toccarmi, di non toccarmi brutto bastardo, che
non gli fregava niente di me, e io non ero più sua figlia, sua figlia
era morta era chiaro? TUA FIGLIA E' MORTA HAI CAPITO?
Insomma feci la mia sparata.
E dieci secondi dopo averla fatta non sapevo più che altro fare.
Potevo minacciare ma non potevo mettere in pratica le mie minacce,
potevo mettere in pratica certe minacce che però erano proporzionalmente
insufficienti alla situazione.
Mi sentivo morta, era vero. Come un soldato mandato in guerra con una
cerbottana.
Più semplicemente ero troppo piccola, non avevo mezzi, non avevo
alleati. Avevo solo nemici.
Quando sento le persone rimpiangere l'adolescenza e quel tipo di
gioventù acerba io penso che siano tutti pazzi. E' orribile essere
giovani. Essere ragazzi è una crudeltà.
Forse quella gente non ricorda bene cosa significa essere del tutto
irrilevanti davanti alle cose che succedono.
Cosa significa non avere la possibilità di cambiare le cose, quando ti
succedono.
Mai più capiterà di trovarsi in una situazione simile, se non forse in
estrema vecchiaia, o in malattia.
Essere del tutto e completamente impotenti di fronte agli eventi che ti
preme cambiare.
Ed è una condizione che sei costretto a vivere quando hai ancora le ossa
fragili, senza nemmeno il libretto delle istruzioni che ti spieghi come
si rimontano i pezzi.
Non piansi.
Senza piangere lasciai lì mio padre col naso sanguinante e il contadino
col culo per terra.
Tornai dal mio cane e lo feci passeggiare a lungo quella sera, e gli
parlai molto.
Lo portai lontano per i campi e lo avrei lasciato scappare, ma Mimì non
sapeva scappare. Lo avrebbero ripreso di sicuro, perché avrebbe lasciato
dietro di sé una scia di animali e cristiani feriti.
Quella sera, più di tutte le altre, mi fu difficile lasciarlo solo nella
casa di campagna. Lo riaccompagnai che erano le nove passate e ad
aspettarmi c'era mio padre con un cerotto sul naso, il contadino si era
volatilizzato. Avevo sperato che mio padre se ne fosse andato, ma
ovviamente era ancora lì e con un'aria molto preoccupata.
Mi chiese molto duramente dove diavolo ero stata. Era stato in pensiero,
ero una disgraziata, si vergognava di me.
Io mi vergogno di te, gli risposi.
Alzò appena una mano per cercare di colpirmi e io gli dissi che se lo
faceva avrei lasciato il guinzaglio. Mimì aveva cominciato a ringhiare
non appena lo aveva visto e ora abbaiava furiosamente.
Mio padre riabbassò la mano e non disse niente. Mi guardò soltanto.
Come si guarda un mostro.
RITORNO A CASA
Dissi a mio padre che sarei tornata a piedi, e così feci.
Rincasai che erano quasi le undici.
Non sarei voluta tornare mai più. Sapevo cosa mi aspettava.
Nel tragitto piansi molto e pensai a mille cose tutte insieme, ma sopra
ad ogni cosa pensai a quello che avevo detto a mio padre e a come lui mi
aveva guardato.
La condanna a morte di Mimì era un pensiero che aleggiava a pochi
centimetri dal mio cervello, era un pipistrello nero che mi svolazzava
davanti senza posa e senza senso.
Era un pensiero che non si lasciava acchiappare.
A casa c'era mia madre che mi aspettava, in vestaglia, seduta in
soggiorno.
Aveva una tazza di camomilla in una mano e la sua testa nell'altra.
L'unica luce della stanza era quella della televisione.
Mi squadrò da cima a piedi e per un attimo non seppi se aveva intenzione
di uccidermi o di mettersi a piangere.
Invece parlò.
Mi chiese come stavo.
Stò bene, mamma. Le dissi.
Mi chiese di sedermi, poi si alzò e andò in cucina. Tornò pochi secondi
dopo con una tazza identica alla sua e me la mise davanti.
Poi si sedette.
Mi aspettavo una chiassata imperiale, anche qualche schiaffo a dire la
verità, ma non mi aspettavo quello.
Mi abbracciò fortissimo e mi disse che non capiva cosa mi stava
succedendo, che non capiva e non avrebbe mai capito perché ero troppo
diversa da lei, e non sapeva come fare per cambiare le cose. Che stava
impazzendo a vedermi ridotta così.
Poi mi disse Cristiana tu sei forte ma anche troppo sensibile. Cambia
una delle due cose figlia mia, sennò starai sempre male.
MIMI A MORTE
Mio padre aveva paura di me, ma sapeva che comunque non avrei potuto
fare niente. La paura che aveva verso di me era una cosa che andava
aldilà di quella specifica vicenda, continuò ad aver paura di me anche
successivamente, ed è una paura che non lo ha mai abbandonato.
Semplicemente, credo che sia lo sconvolgimento che prova un genitore nel
capire che suo figlio è cresciuto, e che ormai è fuori dal suo
controllo.
E' una paura che certe volte si trasforma in rispetto col passare degli
anni, e infatti mio padre da allora mi ha sempre rispettata e anche
oggi, nonostante la sua malattia, tiene in gran conto quel che dico.
Praticamente sono l'unica persona che ascolta, o che non fa finta di
ignorare.
Ma se quell'episodio di violenza fu paradossalmente il primo passo verso
la mia credibilità ai suoi occhi, d'altro canto fu del tutto inutile ai
fini di questa specifica vicenda.
Mio padre sapeva quali erano i punti deboli delle mie offensive.
Potevo spaventarlo ma non comandarlo, perché ero ribelle ma non avevo
nessuna autorità su di lui, l'autorità non si conquista con la
ribellione. Avevo ottenuto la stessa intoccabilità che prima era solo
sua, ma non l'autorità.
Era sempre lui che portava i pantaloni in casa. Li portava malissimo ma
questo non cambiava il fatto.
Per un po' non successe niente ma alla fine mio padre riuscì a farsi
morsicare da Mimì per via dei suoi modi.
Un giorno mi spuntò alle spalle all'improvviso mentre stavo giocando con
il mio cane, per dirmi che era ora di andare. Lo fece con un tono di
voce molto brusco e avvicinandomisi troppo in fretta. Mimi credette che
volesse farmi del male e per difendermi lo aggredì.
Io in quel momento ero seduta sull'erba con il guinzaglio in mano e non
ero nella posizione ideale per trattenerlo. Riuscii a bloccarlo subito,
ma mio padre si prese comunque un morso su una mano.
Non molto grave a dire il vero, una ferita piuttosto superficiale, ma
che divenne l'esempio emblematico della malvagità del mio cane.
Mio padre mi urlò chiedendomi se ero soddisfatta ora, se ero contenta.
Mi disse che era un cane pericoloso e pazzo, che mordeva anche i suoi
padroni e che prima o poi avrebbe morso anche me.
All'improvviso mio padre si preoccupava molto della mia incolumità,
guarda guarda che novità.
Il fatto che lui non fosse mai stato il suo padrone, e che Mimi non si
sarebbe mai sognato di mordermi fu considerato irrilevante, e così Mimi
venne abbattuto pochi giorni dopo.
FINE DEL MIO CANE
Fu fatto di mattina, una mattina qualsiasi, senza specificarmi quale. Il
giorno prima Mimi era vivo, il giorno dopo Mimi era morto.
La scuola era finita, e ormai io andavo a trovarlo anche al mattino,
soprattutto dopo quel che era successo con mio padre. Sapevo che avrebbe
chiamato il veterinario e che lo avrebbe fatto uccidere, e pensavo che
se avessi piantato un bel casino, ma di quelli parecchio grossi, il
veterinario se ne sarebbe andato scandalizzato. Non era un gran che come
piano, ma era tutto quello che potevo fare.
Purtroppo mio padre pensò la stessa cosa, e considerò quante probabilità
ci fossero che io tramassi qualcosa di abominevole contro le sue
volontà. Deve aver concluso che le probabilità erano elevatissime, e
così tenne un comportamento da ladro.
Sapeva che non arrivavo mai prima delle undici, perché la sera uscivo e
il mattino dopo raramente mi svegliavo prima delle dieci.
Così lo fece fare alle nove di mattina, mentre io ero a casa a dormire.
Non fu difficile per lui far finta di niente la sera prima, a cena, e
così quella notte andai a dormire con la solita ansia, ma senza
sospettare che mio padre me lo stesse mettendo dritto dritto nel culo.
Così facendo mi tolse di nuovo il mio cane, e questa volta
definitivamente. Mi impedì di salvarlo, e nel caso peggiore, di farlo
morire sulle mie ginocchia, con le mie carezze sul corpo, e la mia voce
nelle orecchie.
Invece morì sotto gli occhi freddi dei suoi nemici, senza di me, che gli
avevo promesso di non lasciarlo mai. Gli venne fatta un iniezione
letale, che gli lasciò qualche minuto di vita, in cui forse ha avuto
tempo di odiarmi per averlo tradito. Non ho mai saputo dove si trova la
sua tomba, se ne ha una.
CONCLUSIONI
Quel che successe dopo è scontato.
Piansi molto e per molto tempo. Quel dolore andava e tornava a ondate
imprevedibili, e mi lasciava ogni volta debole e convalescente, come
dopo una malattia che ti ha fatto molto male ma che non ha avuto la
faccia tosta di ucciderti.
Quel dolore se ne andò lentissimamente, impercettibilmente, giorno dopo
giorno, fino a che non sparì quasi del tutto e venne sostituito da altre
cose.
Forse mio padre si aspettava una crisi isterica da parte mia, al suo
ritorno, quel giorno. Una crisi isterica violentissima a cui avrebbe
dovuto far fronte, e così si era preparato una faccia consona da
sbattermi davanti, una volta varcata la soglia di casa. Sapeva di averla
fatta marcia. Almeno così penso io. Quella è l'impressione che mi diede
quando lo vidi rincasare: con una placidità quasi annoiata, fintissima,
tradita dagli occhi neri come due punte di spillo.
Ma quella crisi isterica non arrivò mai.
E non arrivò più nulla per lui, da parte mia, per molto molto tempo - fino a quando gli riscontrarono la malattia - circa quattro anni fa'.
Non lo minacciai e non gli dissi quel che pensavo di lui, né che lo
volevo morto né che lo odiavo, semplicemente vivevo come se lui non ci
fosse più, o se non ci fossi più io.
Una volta, tre anni prima, mi aveva trattata malissimo a tavola, davanti
a tutti, senza un motivo valido, e io avevo deciso che non gli avrei
parlato più. Così avevo fatto. Ci avevo messo molto poco a capire che la
situazione non era cambiata molto rispetto a prima, che era inutile non
parlargli, perché non gli avevo mai parlato e lui non aveva mai parlato
a me. Ne rimasi sconvolta perché all'epoca gli volevo molto bene e
cominciavo a dubitare che lui ne volesse a me.
Questa volta però non mi sconvolsi di nulla, erano passati solo tre anni
da quell'episodio ma sotto certi punti di vista ne erano passati mille.
Questa volta ignorarlo non mi pesava affatto. Questa volta pesava a lui.
Cercò a suo modo di rimediare, lo avvertivo.
Ma la porta che avevo lasciato aperta - a volte disperatamente - per sedici anni, si era chiusa.
Io avevo un cane.
Se non ci fosse stato le cose sarebbero andate diversamente.
Forse sarei arrivata lo stesso a certe conclusioni, ma più tardi, e con
meno violenza, di certo con meno dolore, e questo mi avrebbe scoraggiato
dal prendere certe decisioni.
Non appena presi la Maturità, due anni dopo, me ne andai di casa e venni
a vivere qui.
Ho avuto la vita più facile perché mia madre ha potuto mantenermi, ma so
che se non avesse potuto sarei partita lo stesso, a diciotto anni ero
già abbastanza grande da sapermela cavare, se serviva.
E soprattutto, al di sopra di ogni cosa, volevo andare via. Non mi è mai
mancata la casa ad Ancona, neppure i primi tempi, quando qui era tutto
nuovo e non conoscevo nessuno, tranne Marika che era partita con me.
Il primo mese vidi spesso Marika piangere di nascosto, per nostalgia, e
io in un certo senso la invidiavo. Lei era partita, io ero scappata.
Dopo la morte del mio cane, feci come se fossi sola. Passavo del tempo
con mia madre, volendole sinceramente bene, ma non mi fidavo più neanche
di lei, perché lei sbagliava, come chiunque altro, lei sbagliava
esattamente come sbagliavo io, e allora tanto valeva che della mia vita
me ne occupassi personalmente. Non mi appoggiai più a lei quando mi
sentivo insicura, quando mi sentivo sola. In realtà non mi appoggiai più
a nessuno.
Il mio cane mi aveva insegnato ad essere autonoma, e un'altra cosa
ancora, importantissima. Mi aveva insegnato i miei limiti. A sedici anni
si pensa di poter fare tutto, cambiare il mondo è una meta
raggiungibile. Più tardi si scopre che non è così. Io invece lo scoprii
subito.
Scoprii che ero indifesa e debole, scoprii cosa vuol dire perdere quel
che si ama, che è una cosa che può succedere e quando succede non puoi
farci niente. E nonostante vai avanti e continui a vivere, il peggio può
ferirti ma non ti uccide mai.
Ecco quello che aveva fatto quel piccolo cane.
E' principalmente grazie a lui se, nel bene e nel male, oggi io sono
così.
A volte penso se fosse arrivato a casa mia più tardi, qualche anno fa, o
adesso. Se avessi avuto ventisei anni invece di sedici.
E' un pensiero che placa un po' il grande senso di colpa che mi porto
dentro, perché a quest'ora sarebbe vivo e felice grazie a me, e non
morto ammazzato a causa della mia impotenza.
A volte penso che se avessi fatto scelte diverse forse sarebbe ancora
vivo, e non c'è nessuno nella mia testa che mi dice "no, escludilo".
Non ho mai perdonato mio padre per quel che ha fatto, ma non ho mai
perdonato neppure me stessa per quello che non ho saputo fare.
EPILOGO
Mio padre ha l'Alzheimer.
I primi sintomi della malattia si sono manifestati circa quattro anni
fa, ma quella è una malattia che sa aspettare prima di fare cuccù.
Probabilmente ce l'aveva già da qualche anno prima.
Attualmente ha perso molto della sua lucidità, il controllo degli
stimoli e in parte l'uso delle gambe.
Ogni volta che vado a trovarlo nella vecchia casa ad Ancona lo vedo
sempre un pochino peggio, e so che quel che provo è affetto per lui.
Quando sono lì passo del tempo con lui, lo aiuto ad alzarsi e lo
accompagno sulla terrazza quando vuole fumare, faccio attenzione che
prenda tutte le pillole dopo i pasti.
Nonostante sia mia madre che si occupa di lui continuamente è a me che
presta attenzione, come se dipendesse da me, e non da lei.
Mi ritrovo ad osservarlo in certi momenti, e credo che capisca ancora
molto, più di quello che mia madre o mia sorella credano, a volte si
comporta da persona dispettosa, fa i capricci e si impunta, e se loro
pensano che sia tutta colpa della degenerazione della malattia, beh, non
io. Credo che a volte ci faccia apposta per esprimere il suo dissenso, i
suoi umori e quel poco che resta dei suoi desideri.
Ho pensato molto a lui negli ultimi tempi.
Ora sono abbastanza grande da capire certe cose che prima mi sembravano
assurde. Posso non perdonarle, ma posso capirle.
Quel che so di lui è quel che mi ha detto mia madre, e quel che vedevo
con i miei occhi. In entrambi i casi non si tratta di testimoni
imparziali.
Quel che penso di lui è più una speculazione mentale che si è
strutturata con gli anni, e quindi forse è una menzogna, mio malgrado.
Non so perché mio padre si comportasse così con me, e con mia sorella.
Quando avrei potuto chiederglielo ero troppo piccola e debole, ora che
vorrei farlo è lui ad essere debole, e così, non lo saprò mai.
Le persone crescono e perdonano, se son riuscite a crescere bene.
E così forse penso che su certe cose io non ci sia riuscita, perché vedo
il mio cane ucciso da mio padre, dal suo egoismo e dal suo modo
insensibile di trattare le cose, e non riesco a perdonarlo perché lui
trattava me allo stesso modo, anche se non mi ha ucciso.
Lui trattava tutti allo stesso modo.
Vorrei sapere le sue ragioni, vorrei delle giustificazioni, anche se so
che non ne esiste una buona.
Vorrei sapere perché stò qui a scrivere su di lui, e a colpevolizzarmi
per lui, vorrei sapere se ne vale la pena tutto sommato.
Invece ho la sua tuta da ginnastica sformata e i suoi occhi indecifrati,
e il suo culo secco stampato sul divano di casa, ecco tutto.
E ho una foto del mio cane, una sola, dove eravamo ancora cuccioli tutti
e due.
Cap. Ripley