|
JERUSALEM DI TURRICELLA
Liberamente tratto
dall' "Historia Domini Culumbarum"
("Historia tertia" del Codex Turricellanus di
Martino da Rieti)

Ginulfo
Ginulfo, conte di Benevento, era un uomo sanguinario e
malvagio, e se la sua anima era brutta il suo volto ne era lo
specchio.
Piccolo di statura, con colorito giallognolo e
malaticcio tipico di chi è avvezzo ad ogni vizio, aveva una
folta barba corvina e radi capelli. Una bocca sogghignante
racchiudeva denti grigi e marci.Non c’era al mondo un
delitto che non aveva commesso o nefandezza che non avesse
conosciuto.
Forte del terrore che esercitavano i suoi
sgherri ed in assenza del Duca, suo signore, impegnato in una
lunghissima guerra, affamava i propri sudditi con sempre nuove
tasse e gabelle. Taglieggiava perfino le chiese poste sui suoi
territori, pretendendo parte delle decime e delle offerte.
Serafino, vescovo di Benevento, uomo pio e generoso, era
intervenuto molte volte per tentare di mitigarne l’animo, ma
ne aveva avuto solo ingiurie e derisione.

Il conte amava molto la caccia e più di una
volta aveva inseguito una preda per un’intera giornata,
sfiancando cavallo e cani. Si fermava, poi, nelle case dei
sudditi più facoltosi, pretendendo la più nobile delle
accoglienze. Se la caccia non era stata propizia, sfogava la sua
ira depredando delle cose migliori coloro che l’avevano
ospitato.
Amava molto il vino e suo compagno di bevute
era Egario, un prete originario di un borgo ai confini con la
marca foggiana, che da tempo aveva anteposto vino e oro a nostro
Signore Gesù Cristo.
Egario prestava i soldi ad usura a contadini ed
artigiani, pretendendo a scadenza interessi tanto elevati che
molti, per far fronte ad un piccolo debito divenuto enorme,
avevano perso tutto, terre, case, botteghe e bestiame. Egario
serviva il conte come informatore, traendone in cambio vino e
protezione.
Ginulfo aveva fatto venire da Basilicæ, uno sperduto
villaggio che si trovava nella parte settentrionale del ducato
sannita, una strega di nome Dimonda esperta in filtri, fatture e
veleni. Con lei passava giornate intere in un’ala del
castello, compiendo riti innominabili ed evocando spiriti
immondi.
In quelle sale avevano accesso solo la strega,
Egario ed un servo del conte, un uomo senza scrupoli, spesso
usato come assassino prezzolato. Questi aveva gli occhi che quasi
gli fuoriuscivano dalle orbite, per la qual cosa era chiamato da
tutti Occhidipecora.
Il conte divenne sempre più audace ed arrogante, tanto
da pretendere perfino una tassa sul pane. Il popolo, già
prostrato dalla sua ingordigia ed inferocito dal nuovo balzello,
infine si ribellò ed una notte assalì in massa il castello.
Ginulfo, resosi conto che le guardie non
avrebbero potuto sostenere l’impeto di quella marea umana,
decise di fuggire per un passaggio segreto e con lui preferirono
tagliare la corda il suo servo, Egario e Dimonda. Fu al prete che
venne l’idea di passare, per la cattedrale, a quell’ora
deserta ed incustodita prima di abbandonare la città,.

Forzarono facilmente la porta e si diressero in
una cripta, di cui pochi erano a conoscenza dove trafugarono le
veneratissime reliquie di San Bartolomeo ed il cospicuo tesoro
della cattedrale. Misero tutto in un grosso baule che sistemarono
su di un cavallo. Solo a questo punto si resero conto che mancava
loro una cavalcatura. Dopo alcuni attimi di smarrimento e
spaventato dalla prospettiva di cadere nelle mani dei rivoltosi,
il conte fece un segno al suo servo che prontamente comprese il
messaggio. Occhidipecora invitò Egario a montare sul suo cavallo
e mentre questi infilava il piede nella staffa, lo pugnalò a
morte. Compiuto quest’ultimo misfatto si allontanarono dalla
città.
Ginulfo aveva intenzione di raggiungere suo cugino
Astolfo, duca di Bari e chiedergli un esercito. Il mattino dopo
giunsero in un borgo fortificato, Turricella, dove si fermarono
per riposare. Il conte pensò che era poco prudente fidarsi di
suo cugino e che sarebbe stato meglio nascondere il tesoro
perciò, dopo che si furono ristorati, presero a salire il colle
e si portarono in un luogo selvaggio ed isolato chiamato il Bosco
della Fajana. Si fermarono in una radura, ai piedi di una quercia
maestosa, dove Occhidipecora cominciò a scavare una profonda
fossa.
Quando ritenne che questa fosse adeguatamente
profonda, si fermò per riprendere fiato. Il conte gli chiese se
fosse disposto a rimanere lì a custodire il tesoro. Al servo
brillarono gli occhi per la cupidigia ed accettò senza
esitazione.
"Appena questo vecchio imbecille sarà
partito – pensò – disseppellirò il tesoro e me ne
andrò a Napoli, dove nessuno mi conosce e farò il signore per
tutta la vita".
Ginulfo allora gli disse: "- Custodisci
questo tesoro per me o per chi viene in nome mio. Consegnerai la
cassa solo quando saranno pronunziate queste parole
Sette vipere
nel fosso
un villano
hanno morso
Sette i diavoli
furibondi
Chiusi in antri
bui e profondi
Ma mille teste
recise il moro
Rendimi, o servo,
il mio tesoro".

Fece ripetere diverse volte la
formula a Occhidipecora finché non l’ebbe imparata a
memoria, poi , mentre questi gli dava le spalle lo trafisse con
la spada da parte a parte. Sgranando incredulo gli occhi cadde a
terra e mentre, annaspando nell’agonia mordeva la terra, la
strega cantilenò un sortilegio. Come rese l’ultimo respiro,
la sua anima si trasformò in un falco che volò verso il cielo,
lanciando un grido di disperazione. Fu seppellito insieme alle
reliquie ed al tesoro e così le ossa di un Santo si trovarono
interrate insieme a quelle di un assassino.
Serafino
Ma
la natura non poteva sopportare tale assurda ed empia promiscuità
e si ribellò.
Passarono alcuni mesi ed i beneventani
rinunciarono a cercare le spoglie di San Bartolomeo, convinti
oramai che fossero andate irrimediabilmente perse.

Di colpo cominciarono a mutare le stagioni e
si abbatté una grave carestia prima ed una pestilenza poi.
E come sempre succede in questi casi la morte
iniziò a mietere le sue messi, senza fare più distinzioni. Non
risparmiava più nessuno, né vecchi ischeletriti né giovani
vigorosi, né severe madri né gioiose fanciulle.

Andava a visitare i poveri nei loro tuguri ed
i ricchi sotto i preziosi baldacchini, ricopriva di pustole
maleodoranti gli assassini nelle prigioni ed i chierici nelle
case del Signore. Bande di saccheggiatori passavano di casa in
casa a ripulire le dimore abbandonate e dappertutto si sentiva
solo il lamento dei moribondi ed il tocco funebre delle campane.
Branchi di cani selvatici si contendevano brandelli di cadaveri
frettolosamente seppelliti in fosse poco profonde. La gente
disperata si riversava nelle chiese per implorare perdono e
salvezza.
Il vescovo Serafino passava le sue giornate in
preghiera, umiliando il suo corpo con frequenti e prolungati
digiuni. Una notte, prostrato dalla mancanza di cibo e di sonno,
mentre era in preghiera si assopì ed ebbe una visione che lo
impressionò molto.

Sognò che una torma di diavoli trascinava
l’anima di Ginulfo nel luogo dell’eterno dolore. Poi San
Bartolomeo che si doleva che le sue ossa fossero frammischiate a
quelle di un assassino e che nulla aveva tentato il suo gregge
per recuperarle.

Il Santo indicava un paese arroccato su di una
collina, dove volteggiavano decine di colombe, tortore e
rondini. Da una foschia uscì giovane dai lunghi capelli
castani, che con un fischio chiamava le colombe, le quali si
fermavano ai suoi piedi e si facevano prendere e carezzare. Il
ragazzo parlava con loro e guardava preoccupato verso oriente,
dove si stavano addensando cupe nubi.
Il vescovo si svegliò di colpo, tremante e
agitato. Cantò una laude in gloria a nostro Signore,
ringraziandolo commosso del segno ricevuto. Si rese conto che
era ancora notte fonda, tuttavia svegliò il suo servitore ed il
suo assistente e diede disposizioni per un lungo viaggio.
Partirono all’alba con tre muli, tenendo sempre il sole di
fronte, alla ricerca del signore delle colombe
Turricella

Turricella era un villaggio con meno di 500 abitanti, per
lo più contadini ed artigiani. Aveva una struttura molto strana,
differente dagli altri villaggi. Innanzitutto le abitazioni,
anzicché arroccarsi nella parte più alta del colle, erano state
costruite nella parte più bassa. Ma questo aveva una logica
difensiva: difatti l’unica strada di accesso al paese era un
viottolo strettissimo, che si incuneava tra due colline e
costeggiava il Rivo Nantri (ora Nandri), un limpidissimo
ruscello che nasceva e moriva nelle terre di Turricella ( il
fiume di Noi Altri, contrattosi poi in Nantri). Un esercito, che
avesse voluto attaccare il paese da quella parte, si sarebbe
trovato in una strettoia dove a stento potevano manovrare due
cavalli per volta. Guadato il corso d’acqua, ci si imbatteva
in due sentieri : Uno stretto e scosceso, portava ad una dei tre
ingressi del paese, Porta Nuova, l’altro largo tanto
da poterci passare un piccolo carro, costeggiava la parte
settentrionale del colle e portava alla seconda porta, il Varo
del Castagno.
Porta delle Casaline era l’ultimo
accesso al borgo ed era collocata sul lato sud orientale
.
Le case addossate l’una a l’altra facevano da
cinta muraria. Le entrare delle abitazioni erano tutte collocate
sulle vie interne, mentre solo piccolissime finestre e feritoie
prendevano luce dalla parte esterna. Qualcuna aveva un
piccolissimo varco, munito però di robusti cancelli in ferro,
che per legge dovevano essere sempre chiusi prima del tramonto.
Questi davano su minuscoli orti dove erano situati ripari per
galline, maiali e pecore. Le tre strade di accesso erano sbarrate
da porte, aperte le quali, si passava per un sottopassaggio di
una decina di metri. L’entrata della Portanuova immetteva
nella piazzetta del Vecchio Olmo, mentre quella del Varo del
Castagno portava nei pressi della chiesa di San Nicola, anch'
essa integrata nel sistema difensivo del borgo. Altre viuzze e
sottopassaggi si diramavano dalle due principali. Un tunnel, che
passava sotto quasi tutte le case della parte settentrionale del
paese, portava dalla chiesa ad una piccola torre di difesa che
proteggeva il lato nord. Una torre più grande e più munita era
posta isolata in un luogo più alto a protezione del lato sud e
di quello orientale. Ad occidente c’era una palude formata
dal Rivo Nantri ed una foresta di noccioli. Il borgo era abitato
da un centinaio di famiglie, per lo più dedite
all’agricoltura. C’erano però anche valenti artigiani:
un fabbri, sarti, vasai, scalpellini, calzolai, bottai.
I terreni vicini al villaggio erano poco
fertili, per cui i contadini dovevano percorre diversi chilometri
per andare ai Campi delle Filette o ai Campi dei Cerasi
a coltivare i campi migliori. Le donne lavoravano piccoli
appezzamenti negli Orti di Nandri, dove potevano anche
lavare i panni. Le vigne davano un buon vino che i Turricellesi
scambiavano con i villaggi vicini.
Nella piazza del Vecchio Olmo c’era la
taverna dello Scudo Spezzato di Mastro Alberto. A sera,
dopo il lavoro, gli uomini si trovavano a bere un boccale di vino
o a giocare con gli astragali . Qualche viaggiatore isolato vi si
fermava per ristorarsi e passare la notte al sicuro.
Le donne, al vespro, andavano a pregare nella
chiesa di San Nicola, dove il buon Martino celebrava le funzioni
religiose .

Jerusalem
Jerusalem era un ragazzo di diciassette anni. Aveva
lunghi capelli castani, ed era più alto della media. Era forte
come un torello ed aveva una grande passione per la caccia, che
praticava, ogni volta che ne aveva l’opportunità, nei
boschi e nelle foreste dei dintorni . Le sue prede, però non
erano mai tortore o colombe, animali che lui allevava ed amava
moltissimo.

Cacciava con un arco molto potente di legno di
tasso e conservava le frecce non in una normale faretra, bensì
in un turcasso orientale, che aveva ereditato da suo padre.
Con quest’arma era molto bravo e spesso abbatteva
lepri, volpi, tassi e cerbiatti. Per due volte era riuscito a
sorprendere nel Bosco della Fajana un cinghiale e in entrambe le
volte aveva dovuto chiedere in prestito un carro per trasportare
gli prede, preziosissime riserve di cibo per l’inverno.
Era orfano e viveva con sua zia Genoveffa, che borbottava
sempre come una pentola sul fuoco, ma che tutto sommato lo amava
moltissimo. Avevano un campo nei pressi dei Boschi dei Grifi, che
entrambi coltivavano con molta diligenza. Jerusalem passava ore
ed ore con le sue colombe che chiamava con un fischio acutissimo.
Queste venivano a becchettare le granaglie nelle sue mani, mentre
le carezzava e parlava loro come se fossero esseri umani.
Conosceva i suoi volatili uno ad uno e dava loro nomi di nobili
cavalieri e dame, a secondo del colore del piumaggio o del
portamento. Li chiamava Visconte, Principe Saltellante, Cavaliere
grigio, Barone nero, Contessa Bellacoda, Principessa
Occhioazzurri, ma la sua colomba preferita era Regina Bianca, che
aveva un piumaggio di un candore immacolato. Questa sembrava che
comprendesse tutto quello che il giovane le diceva. Spesso le
stava su una spalla ed era sempre la prima a picchiare dal cielo,
tutte le volte che il giovine lanciava il suo fischio.
Quel pomeriggio il ragazzo se ne stava seduto
all’aperto a pensare ad Aurora, la figlia del mugnaio, una
ragazza giovane e flessuosa come un giunco, mentre su di una
roccia di fronte a lui Bianca si puliva le penne col becco. Vide
arrivare da lontano tre uomini a cavallo, che lentamente
costeggiavano il Nandri per prendere poi il sentiero che portava
al Varo del Castagno. Da un paio di anni si vedevano sempre più
persone aggirarsi nei dintorni spinti dalla fame e
dall’epidemia. Quando i viaggiatori furono usciti dal suo
campo visivo, egli continuò a perdersi nei suoi sogni, mentre la
colomba continuò a guardare fissamente nella loro direzione.
Venanzio
Ginulfo
non era riuscito ad ottenere un esercito dal cugino, che, già
impegnato per conto suo in un'altra guerra, non aveva alcuna
intenzione di inimicarsi nobili confinanti. Il conte allora
decise di formare un proprio esercito; ma per questo occorreva
oro, molto oro, per cui doveva assolutamente recuperare la cassa
che aveva seppellito due anni prima. Raccolse un centinaio di
sbandati e delinquenti comuni, ai quali promise oro e saccheggio
e partì alla volta di Turricella in una fosca mattina d'estate.
"Prenderò il paese con un colpo di mano
- pensava - e mentre questi tagliagola saranno intenti a
saziarsi di donne e saccheggio, andrò a disseppellire il
baule".
 Con
sé portò la strega Dimonda che gli era restata fedele in
quegli anni. Con
sé portò la strega Dimonda che gli era restata fedele in
quegli anni.
Tre giorni dopo il cielo era cupo come non
mai. I contadini, temendo di incappare in un diluvio non
andarono nei campi, preferendo restare a casa. Ma dal cielo non
una sola goccia d'acqua cadde.
A
sera Fiorenzio andò nella canonica, portando con sé vino,
miele di acacia ed anche un bel pezzo di maiale. Ma la cena non
fu allegra. Serafino era meditabondo e parlò pochissimo durante
il pasto e si ritirò subito dopo nella sua stanza per pregare.
Martino e Fiorenzio restarono insieme ai due accompagnatori del
vescovo a discutere.
Quella sera c'era molta gente allo Scudo
Spezzato. Come al solito si parlava, giocava e beveva. In un
angolo Malgino, un giovine musico, cantava accompagnandosi con
un vecchio laud ed a stento riusciva a sovrastare il vocio dei
clienti.
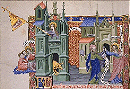
Venanzio,
un contadino delle parti dei Campi dei Cerasi, quella sera aveva
alzato un po’ il gomito e si era addormentato profondamente
nell'angolo meno illuminato della taverna. L'ultimo dei clienti
andò via e Mastro Alberto si accingeva a sbarrare le porte,
quando si accorse del dormiente che russava placidamente. Lo
svegliò senza complimenti e, quando si rese conto che era in
grado di reggersi in piedi, gli mise il cappellaccio sulla testa
e lo mise fuori della porta. A Venanzio occorse qualche minuto
per raccogliere le idee e realizzare dove si trovava, quindi
cantando si diresse giù a Porta Nuova. Questa era stata già
chiusa. Sempre di buon umore e barcollando notevolmente, si
diresse al Varo del Castagno. Ma anche questa porta era
sbarrata. Dopo altri minuti di indecisione, decise di bussare
alla porta di Massimino, un suo compare, che abitava lì vicino.
"Compareeeeee! Compare Massimininoooo"-
urlò più volte fino a che questi, mezzo nudo e visibilmente
seccato venne ad aprire, pregandolo di non gridare.
" Carissimo compare… il migliore
compare del mondo ho io….." - continuò Venanzio
alitandogli sul viso - "mi hanno lasciato dentro…..e non
mi lasciano uscire".
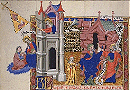
"Fammi dormire con te !" - disse
aggrappandosi a lui per non cadere. Massimino non aveva nessuna
intenzione di ospitare il suo compare quella notte e gli aprì
il cancello del suo orto. Venanzio prese un piccolo sentiero che
lo portò su una strada, solo di poco più larga, che conduceva
agli Orti di Nandri. Malfermo sulle gambe la percorse tutta,
inciampando diverse volte a causa della profonda oscurità e
finalmente arrivò al guado del Nandri. Il ruscello d'estate
aveva una portata minima ed era possibile traversarlo senza
bagnarsi camminando su sassi che affioravano dal suo letto.
Riuscendo a mantenere un miracoloso equilibrio il contadino
riuscì a passare il rivo senza cadere. Ora doveva solo prendere
il sentiero che lo avrebbe portato ai Campi dei Cerasi. Ma aveva
percorso sì e no un centinaio di passi quando sentì il nitrito
di un cavallo. Sobrio abbastanza da intuire un possibile
pericolo si nascose in una macchia di prugnoli selvatici. Giusto
a tempo! Una schiera di cavalieri, preceduta da un esploratore,
che appiedato cercava di seguire il sentiero per guidare gli
altri, gli passò davanti. Erano tutti armati fino ai denti e
silenziosi. Si stavano dirigendo silenziosamente alla volta del
villaggio. Venanzio uscì cautamente dal suo nascondiglio e si
mise a correre tra le spine. Riguadò il Nandri in un punto dove
l'acqua gli arrivava al petto, (ma ora i vestiti bagnati erano
l'ultimo dei suoi problemi) e dopo una corsa folle interrotta da
numerose cadute, riuscì a passare il ponte di legno ed arrivare
alla Porta Nuova. Prese un sasso ed urlando come un maiale
scannato, si mise a percuotere le porte. Si accesero diverse
lampade e poco dopo gli fu aperto. Con i vestiti strappati dalle
spine, sanguinante, bagnato e tremante dalla paura raccontò
tutto. Poco dopo il cupo richiamo della tofa risuonò,
avvertendo tutti dell'imminente pericolo. Anche Ginulfo sentì
il suono e capì che la sorpresa era oramai fallita.
Fiorenzio
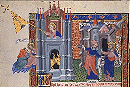
Tutti
avevano sentito la tofa. Il mugnaio e la famiglia con i
contadini che abitavano nei pressi del borgo si precipitarono
tra le sicure mura del borgo. Quelli che abitavano nelle
fattorie lontane, non sapendo né la natura del pericolo né da
dove provenisse, si misero al sicuro nei boschi. Nella torre
grande c'erano solo cinque vecchie guardie del Signor di
Montefuscolo. C'era pace e il presidio aveva più una funzione
rappresentativa che difensiva. Come si diffuse l'allarme e le
persone si riversarono in piazza del Vecchio Olmo e per i
vicoli, interrogando i passanti sulla natura del pericolo, molte
persone si riversarono nella chiesa di San Nicola. Parlò per
tutti Fiorenzio.
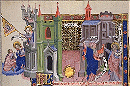
" Non sappiamo chi sono questi cavalieri
- disse - né a quale signore appartengano né qual’è la loro
meta. Può essere che transitino solo per continuare verso Petra
dei Fusi. Tuttavia gente che cavalca a quest'ora di notte non mi
tranquillizza, per cui occorre stare in guardia. Si portino i
bambini al riparo e le donne facciano rifornimento di
acqua". Una decina di uomini fu inviata alla torretta
piccola. Tutti si armarono alla meglio. Non c'erano armi
difensive ma solo archi, picche, asce, daghe e coltellacci. I
torresi nervosamente si disposero all'attesa, ognuno sperando in
cuor proprio che la torma armata, una volta raggiunto il ponte
di legno, deviasse nella direzione di Petra dei Fusi. Ma
l'illusione durò solo una mezz'ora. All'improvviso si sentirono
le urla di una donna che implorava di aprire Porta Nuova. Gli
uomini di guardia, accertatosi che si trattava solo di un uomo e
di una donna, aprirono un battente ed i due passarono per il
sottopassaggio come un soffio di vento. L'uomo disse di essere
un cavaliere pugliese, sorpreso con una serva di sua moglie,
mentre era in viaggio da quelle parti da una banda di canaglie
che li stavano inseguendo. Uno li accompagnò allo Scudo
Spezzato. Dopo pochi minuti arrivarono altri cavalieri che
prontamente iniziarono a colpire con le scuri Porta Nuova e la
porta del Varo del Castagno.
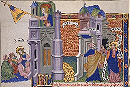
I
predoni, chi appiedato chi a cavallo, si ammassarono tutti in
uno spazio angusto per questo quando dalle finestre e feritoie
cominciarono a partire frecce sassi e acqua bollente,
difficilmente mancarono il bersaglio. I dardi ronzavano come
enormi zanzare e con il loro aculeo cercavano i corpi degli
assalitori e delle bestie. Un paio di cavalli feriti
s’imbizzarrirono portando ulteriore scompiglio e rovina tra i
soldati. Questi non tardarono a capire che la loro posizione era
insostenibile e si allontanarono in tutta fretta, lasciando
tuttavia sul terreno una decina di persone ed un paio di
cavalli.
Poco dopo le fiamme cominciarono a levarsi dai
casolari vicini, dove i soldati sfogavano con il saccheggio e la
devastazione la loro rabbia e frustrazione.
Ginulfo, intanto, insieme a Dimonda, aveva
lasciato lo Scudo Spezzato e si era fatto aprire la Porta delle
Casaline, dicendo di non sentirsi al sicuro e che preferiva,
nonostante la notte, proseguire il viaggio verso Montemiletto,
dove la guarnigione era più munita e la rocca più difendibile.
Bianca
" Una maledetta donnola o
un barbagianni!" – pensò Jerusalem alzandosi dal letto
di malumore e prendendo un attizzatoio dal camino. Le sue colombe
come impazzite lo avevano svegliato da un sonno agitato. Salì la
scaletta che portava nella colombaia, ma non trovò traccia della
presenza di predatori. Tuttavia gli uccelli erano molto nervosi e
si comportavano in maniera stranissima.
Bianca, la sua colomba preferita, saltellava in
continuazione dalla sua spalla alla porta e viceversa. Il ragazzo
restò interdetto. Mai i suoi animali si erano comportati in una
simile maniera. Poi accadde qualcosa d’incredibile: di colpo
tutti i colombi tacquero e si chetarono e in quel silenzio
irreale, la sola Bianca volò su un posatoio di fronte a
Jerusalem e cominciò a guardare il ragazzo dritto negli occhi.
Per qualche istante l’uomo e l’animale si fissarono in
silenzio, quindi Jerusalem sospirò " Ho capito… dammi
il tempo di vestirmi".
Indossò precipitosamente un paio di brache,
prese l’arco, il turcasso con le frecce, un coltello da
caccia e silenziosamente, per non svegliare zia Genoeffa, uscì
da casa.. La sua colomba lo attendeva fuori e lo guidò verso
Porta delle Casaline. A quell’ora la porta era sbarrata e
Jerusalem uscì dal suo orto e aggirò il villaggio portandosi a
sud, verso il colle. Bianca lo portava verso San Mercurio. Quando
vi ci arrivò sentì il richiamo della tofa. Si fermò di colpo:
qualcosa di grave stava accadendo nel villaggio! Il suo primo
impulso fu di tornare indietro, ma gli venne in mente il sogno di
Serafino. Il vescovo era convinto che lui avesse qualcosa a che
fare in quella storia. Fu, comunque, Bianca che, compiendo lo
stesso rituale della piccionaia con i medesimi saltelli dalla
spalla, che lo fece decidere. Pensosamente continuò a seguire il
cammino che il volatile gli indicava.
Camminando lentamente a causa del buio, presero
la strada del Bosco della Fajana e poco dopo la tofa fece
risentire la sua roca voce.
Bianca lo guidò su un sentiero secondario, appena
accennato che si dipanava tortuoso tra gli alberi.
All’improvviso si alzò una brezza che spazzò via le nubi e
la faccia placida della luna illuminò la foresta, rendendo più
agevole il cammino. Jerusalen, poco prima, aveva sentito un
rumore di zoccoli di cavalli provenire dal sentiero principale e
si era fermato per ascoltare meglio. Tuttavia non aveva potuto
stabilire quanti fossero né dove fossero diretti. Comprese,
tuttavia, che non potevano essere amici. Nessun turricellano
sarebbe andato in quel luogo in un'ora simile.
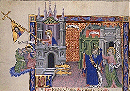
Dopo un altro miglio circa sentì chiaramente
il suono di una voce. Cautamente e senza far il minimo rumore, si
avvicinò ad una radura. Scorse immediatamente due cavalli legati
ad un albero e poco lontano due figure, una delle quali stava
scavando un fossa ai piedi di un maestoso albero.
Si avvicinò sempre di più, prestando
attenzione a non pestare qualche ramo secco né di toccare
qualche cespuglio, il cui fruscio avrebbe potuto tradirlo.
Bianca, intanto, era sparita.
Quando fu ad una ventina di passi si rese conto
che si trattava di un uomo ed una donna. " Un cavaliere
–pensò osservando la foggia dei vestiti la pesante spada
che gli pendeva al fianco. Ma perché mai un cavaliere stava
scavando? Quando la fossa parve sufficientemente profonda
l’uomo esclamò soddisfatto " Eccolo! ". Allora la
donna, inginocchiatasi a terra e coprendosi la testa con un velo,
iniziò a salmodiare un’incomprensibile litania e
all’improvviso un falco, il più grande che avesse mai
veduto, venne a posarsi sul ramo più basso dell’albero. Il
cavaliere con voce risoluta e forte esclamò:
" Sette vipere nel fosso
un villano hanno morso
sette i diavoli……."
Jerusalem, incuriosito da tutto quel rituale
misterioso, commise l’imprudenza di sporgersi dal suo
nascondiglio per osservare meglio la scena ed il falcone,
lanciando uno stridulo richiamo, gli si avventò contro. Il
ragazzo si lasciò cadere terra, evitando cosi gli artigli del
rapace che cercavano i suoi occhi. Anche la donna si mise a
strillare indicando al cavaliere il posto dove si celava il
ragazzo. Questi sguainò la sua spada. Il falco dopo una rapida
virata si diresse di nuovo verso il volto del giovane, ma in volo
fu intercettato da una chiassosa nuvola bianca: erano i colombi
di Jerusalem che contro ogni logica assalivano il predatore. Il
ragazzo si sollevò e si rese conto della minaccia ancor più
grave rappresentata dal cavaliere che gli si avvicinava con la
spada snudata. Non ebbe molto tempo per pensare; istintivamente e
precipitosamente incoccò una freccia e la scagliò senza mirare.
Prima che questa raggiungesse il bersaglio ne era partita già
una seconda. I due dardi, scagliati da una distanza così breve e
da un arco tanto potente, trapassarono da parte a parte il corpo
di Ginulfo e lo inchiodarono ad un tronco in una posizione che
ricordava molto quella di un burattino appeso ad un gancio. La
strega strillando fuggì via.
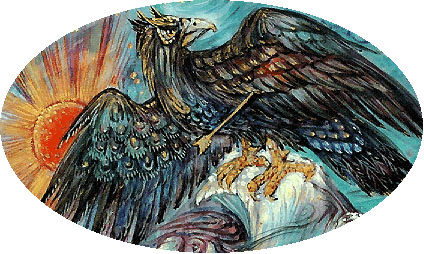
Intanto la strana lotta tra falco e colombe
continuava nel cielo in un turbine di penne che cadevano come
fiocchi di neve.
Jerusalem incoccò la sua terza freccia. Questa
volta tese l’arco con molta cura e prese attentamente la
mira. Quando lasciò andare la corda con un secco schiocco,
questa volò ronzando verso la luna ed intercettò il corpo del
falcone, che cadde in una lenta spirale.
Prima che il ragazzo avesse il tempo di
riprendersi vi fu un altro prodigio: con un boato la grande
quercia si spaccò in due e, dalla fossa che stavano scavando i
due, emerse un baule sul quale stava adagiato uno scheletro.
Epilogo
All’alba non c’era più traccia degli
assalitori, che dopo aver incendiato alcune case isolate e dopo
aver lasciato una decina di loro sul terreno erano fuggiti via.
Jerusalem era rimasto nel bosco per ore,
completamente frastornato e atterrito per il senso di colpa. Non
aveva mai ucciso un uomo. Quando si fece chiaro andò a bussare
alla porta della canonica. Come Martino lo vide, capì che era
successo qualcosa e chiamò subito il vescovo che con un nutrito
gruppo di paesani andò a riprendere la preziosa cassa, mentre un
messo partiva alla volta di Benevento per dare l’annuncio
del ritrovamento delle reliquie. I due cadaveri furono
sotterrati, ma della strega non si seppe più nulla. Serafino
passò molte ore col ragazzo per placarne i rimorsi. Il giorno
dopo vennero un centinaio di cavalieri beneventani, con splendidi
vestiti e armi sfavillanti. Serafino tenne una messa di
ringraziamento ed pretese che Turricellani giurassero di non
cacciare mai più per il futuro né colombe né tortore. Quindi
alzando le mani al cielo disse " Io vi benedico tutti voi
figli miei, ma benedico due volte te, giovine Jerusalem, signore
delle colombe".
Nota del curatore
Spesso mi sono chiesto che fine avranno fatto
Bianca e tutte le altre colombe di Jerusalem? Probabilmente se ne
sono andate in un altro luogo per sfuggire una torma di
imbecilli, che armati di potentissimi fucili le hanno tormentate
per anni.
Eppure io sono convinto che, da un posto sicuro
sotto la collina di Montemiletto, ci spiano attente e silenziose,
aspettando che il nostro paese si popoli di persone migliori. Sta
di fatto che, qualche volta, subito dopo il tramonto, si può
vedere un volo di colombe che parte dai Nucilli e si dirige verso il
Bosco Fajano . Se si presta un po’ di attenzione, si può
aver la fortuna, talvolta, di vedere in quello stormo una
colomba bianchissima, che quasi brilla negli ultimi bagliori del
giorno che muore.
|